
Rachilde, La torre d'amore, Edizioni Croce
Finalmente in italiano il romanzo di Rachilde, La torre d'amore, a cura di Marina Geat, traduzione di Sara Concato, edizioni Croce
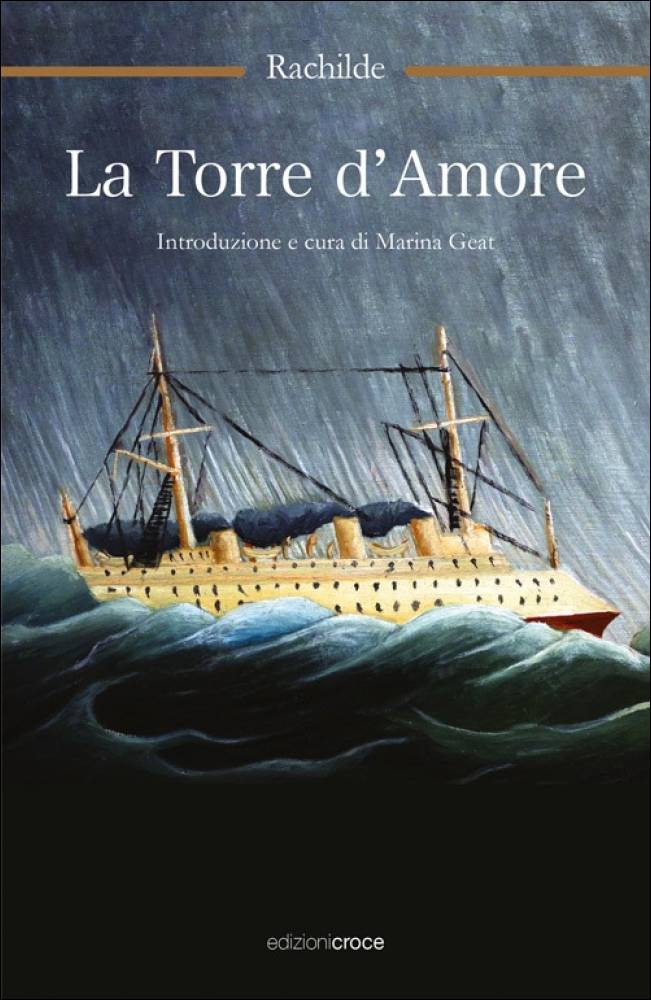 Lunedi, 20/01/2025 - "La torre d’amore" può certamente essere una lettura d’iniziazione alla più approfondita conoscenza di Rachilde, pseudonimo di Marguerite Eymery (1860 – 1953), scrittrice dalla penna di fuoco, poco nota ma in via di riscoperta.
Lunedi, 20/01/2025 - "La torre d’amore" può certamente essere una lettura d’iniziazione alla più approfondita conoscenza di Rachilde, pseudonimo di Marguerite Eymery (1860 – 1953), scrittrice dalla penna di fuoco, poco nota ma in via di riscoperta. Decadentismo, simbolismo, sovversione sono "etichette" che si addicono all'autrice. Tale corredo di termini costituisce una nomenclatura interessante, che non va presa alla leggera. La lettura di questo romanzo, curato da Marina Geat, docente ordinaria di Roma Tre (nonché una delle massime esperte dell'autrice), comporta un vero e proprio shock: la scrittura di Rachilde non perde mai d'intensità. La penna dell'autrice è infatti imprevedibile, sfrontata, sopraffina, scandalosamente vera, capace di sventare qualsiasi ipocrisia.
La storia della "Torre d'amore" tratta innanzitutto di un faro, quello di Ar-Men, posto a metà Ottocento al largo della Bretagna. Un capolavoro di ingegneria per la storia della Francia positivista. Il faro di Ar-Men è quasi una torre Eiffel del mare. Ma vediamo: cos'è, alla fine, un faro? Qualcuno dirà che è una torre d’orientamento per la navigazione notturna. Punto di riferimento per la civiltà e avamposto di luce che si getta negli abissi tumultuosi del mare.
Ecco che comincia a palpitare il simbolismo. Il faro, con la sua luce, fissa in questo caso, assolve a una funzione indispensabile per lo Stato, per la marina. È un’opera stupefacente perché si trova lì, su massi solo apparentemente stabili, soggetti a mareggiate, a venti, a tempeste schiaccianti, al capriccio degli elementi. Ogni parte del faro deve essere progettata e costruita in modo tale da assorbire gli urti del mare, i suoi colpi di testa e di coda, la furia e persino la placida e rovinosa calma dell’acqua cheta. Il faro quindi rappresenta anche la "arrogantia", la hybris in senso greco, l’alterigia dell’uomo che si protende al cielo con la sua torre di Babele.
Cosa crede di essere l’uomo, questo infido animale che si muove e ragiona ancora, quando può farlo, s’intende, come una scimmia poco più eretta?
Dietro all’immagine rachildiana del faro c’è una vera e propria serie di polarità. Intanto, la grave opposizione tra natura e tecnica, ovvero (antinomia attualissima!) tra naturale e artificiale. Eppure c’è dell’altro. C’è la polarità tra l’uomo e la bestia. O se si vuole il contrasto tra l’Ideale dell’Io (lo si chiami come si desidera) e il primate. “Chi potrebbe mai fidarsi della mente di una scimmia?” si interrogava Nietzsche, padre del nichilismo. E poi, la tecnica, l’ingegneria, lo sforzo umano nel dominare la natura ha dietro le sue quinte tutto un recondito teatro di contrapposizioni tra maschile e femminile. E qui bisogna fermarsi, fare una pausa, avere pazienza e notare che se Rachilde è una creatura dirompente, ciò è vero in ragione del suo sfuggire a ogni categoria.
Rachilde è una donna. Sì, d’accordo, biologicamente lo è. Ma cosa possiamo dire di quella personalità che è anche (benché non esclusivamente) il frutto di una rete di riconoscimenti coscienti altrui? Tematica prirandelliana. Rachilde fece in modo di poter circolare in società, nella Parigi del suo tempo, con abiti maschili. Ma non proprio sotto "mentite spoglie". Non è un Mattia Pascal che si finge Adriano Meis. Il punto per lei era un altro: ottenere i diritti e la reputazione riconosciuti agli uomini, agli individui di sesso maschile, pur essendo nata donna, con un corredo cromosomico inferiorizzato.
Rachilde, si vede, inserisce l’ago nel punto nevralgico dell’ipocrisia sociale. Lì, dove la società arriva a mentire a se stessa, lei sguaina la penna e insiste.
E poi c’è lo pseudonimo. Moltissime donne scrissero sotto pseudonimo. Viene in mente la contemporanea, diciamo così, George Sand. Una donna combattiva, forte, militante, sensibile, passionale. Rachilde non è uno pseudonimo qualunque, è anche una voce che viene, sembrerebbe, dall’oltretomba. È un personaggio che la giovane Rachilde tira fuori da una seduta spiritica.
Di nuovo verrebbe da citare Pirandello e quella credulità nella metapsichica e nei fenomeni paranormali che erano così in voga tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, forse perché in quel periodo i limiti dello scientismo si sono allentati, inglobando per osmosi qualcosa che aveva il carattere delle pseudoscienze. Si preparava, del resto, il substrato per il nazifascismo e la “difesa della razza”.
Rachilde, insomma, sfugge alle categorie. L’androginia del suo pensiero fa impressione. Ci sono passi del libro che sembrano pensati (sviluppati in forma spontaneistica più che mai adesiva a quella forma mentis) da un operatore portuale della Brest di fine Ottocento; e ci sono brani che sembrano stesi dalla mano incantevole di una Virginia Woolf. Possibile? Lo è, a quanto pare.
Al primo caso tipologico appartengono quei passi che fanno riferimento al bisogno che ha Jean Maleux di possedere una donna. C’è una certa rozza sostanza, qualcosa di semplice e schietto che si mescola a un senso concreto e pragmatico del contatto con le donne. Le donne servono, anzitutto, per non impazzire, per ancorarsi alla terra, per sentire di voler tornare (si sa, un marinaio deve averne motivo).
È anche brutalmente maschile lo sguardo che Jean Maleux ha sul vecchio Barbabas. Analogie e paragoni sono presi di peso dall’esperienza semplice e straziante del mare. Barbabas si muove come un granchio ricurvo, ha quasi delle pinze (delle chele appuntite) al posto delle mani. Si lecca i palmi e li espone all’aria per capire la direzione del vento. Piscia senza pudore, e senza remore inquina l’aria con i suoi escrementi. Il modo in cui Jean ne scrive è assolutamente credibile. La franca nonchalance è quella di un uomo abituato agli uomini rudi. A quegli uomini a cui può mancare al massimo una donna lontana e del buon vecchio rum.
E poi ci sono altri passi, come il seguente che indugia sulla luce filiforme che si protende sul volto del protagonista: “Il riverbero veniva dalle fessure del legno, e un enorme calore lo accompagnava. Faceva come dei fili di luce, che danzavano, volteggiavano, mi solleticavano le guance come ali di api”.
In questo volume, curato da Marina Geat e tradotto da Sara Concato, esperta di letteratura francofona, si rende finalmente giustizia alla grande esperienza letteraria di Rachilde. Il modo che ha Sara Concato di tradurre è davvero professionale, nel senso che coglie il centro del bersaglio semantico, sfumando adeguatamente il punto di colore, che si intoni al contesto e alla frase entro cui la parola è inserita, scegliendo ove possibile un significante che renda l’idea dell’impasto di prosodia e consonanza, tutto ciò senza mai gonfiare lo stile: dando semmai ragione a quella sobria, talvolta scabra semplicità che è nell’originale. A volte valorizzando, con un’esattezza chirurgica, l’innalzamento stilistico promosso dall’autrice.
In tutto ciò, stile a parte, ci sono temi tutt’altro che trascurabili. Il vecchio Barnabas è ormai più una bestia che un uomo. Così lo hanno reso il servizio indefesso e la lunga solitudine nel faro di Ar Men. È ormai un disilluso cinico. Le donne? Squallide traditrici che ti fanno cornuto. Jean scoprirà che il vecchio, pazzo, psicotico, inquietante, ha delle mostruose abitudini. Così è diventato per l’ululato del vento turbinoso, per lo schiaffo continuo delle onde inclementi. La personalità (o quel che ne resta!) di Barnabas si regge tutta sul puntello delle mansioni inerenti alla gestione stretta delle lampade del faro. Petrolio, stoppini, rabbocchi, bruciatori. Cos’altro? Barbabas ormai non sente nemmeno il sapore dell’aceto: nell’insalata mette un po’ di petrolio. Eppure canticchia che il faro è la torre d’amor. Quanto sia perverso il suo “amor” sarebbe stato meglio non scoprirlo. Chi ha un po’ di stomaco leggerà il tenore degli incontri di Barnabas e in che senso è vero che aspettava il momento più giusto per incontrare le donne, ed usarle.
Il tema del femminicidio c’è, coniugato a quello dell’infedeltà. Sembra un grande classico senza variazioni sul tema: invece no. Leggete "La torre d’amore" e vedrete che l’angoscia più grande sarà scoprire, con profonda inquietudine e riluttanza, che il lettore prova persino una forma (dolorosa e ripudiata) di compartecipazione per l’assassino. A che pro? Rachilde è una specie di antidoto al buonismo borghese. Tira fuori il peggio che abbiamo nascosto sotto al tappeto. Esige una catarsi. L’analisi è spietatamente lucida. Rachilde non è una lettura per tutti. Eppure è una lettura che tutti dovrebbero augurarsi di poter fare.
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®



Lascia un Commento