
Donna blu di Antje Rávik Strubel
«In una lingua corretta […] una come lei non esisteva proprio»
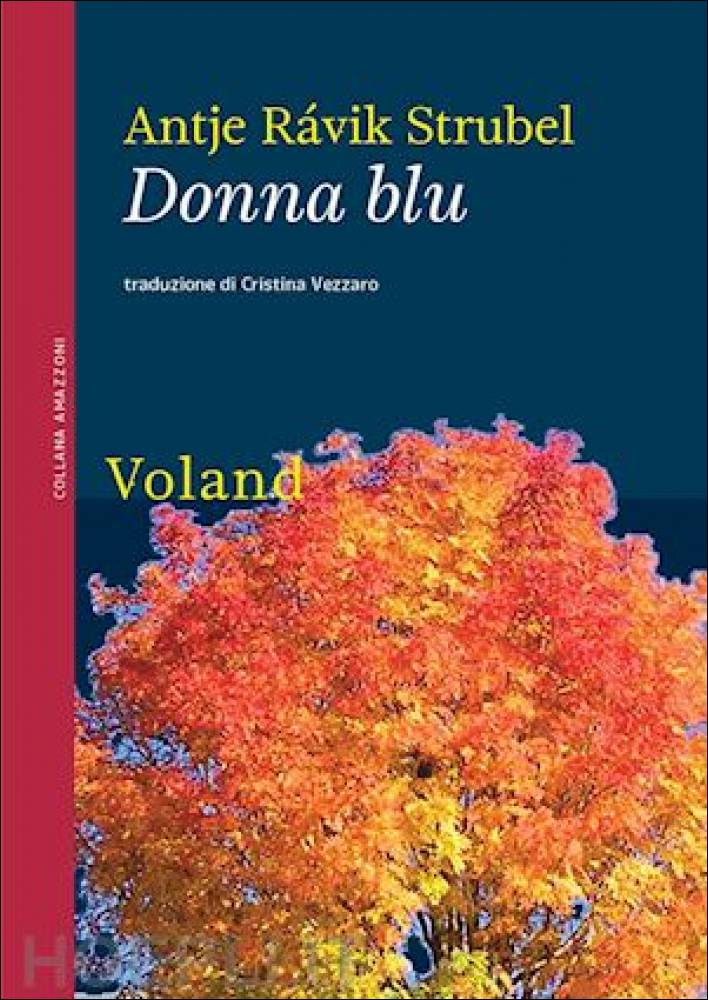 Giovedi, 12/10/2023 - Antje Rávik Strubel è autrice e traduttrice tedesca originaria di Potsdam, che nel 2021 ha scritto Donna blu (Voland, traduzione di Cristina Vezzaro, 2023). Il romanzo racconta la violenza sessuale subita dalla protagonista Adina Schejbal, che dopo aver attraversato «tre confini fra quattro paesi europei» si ritrova a vivere in un appartamento di una palazzina a Helsinki, «un paese che non conosce, un paese del Nord, dove gli alberi sono diversi e la gente parla una lingua diversa, dove l’acqua ha un gusto diverso e l’orizzonte non ha colore». Nata e cresciuta ad Harrachov, nei pressi dei Monti dei Giganti, e figlia della Rivoluzione di Velluto che portò alla dissoluzione della Cecoslovacchia, Adina deve ora fare i conti con la difficoltà di raccontare il dolore in un mondo che sembra non prestarle ascolto. A correre in suo aiuto è una misteriosa figura, la donna blu, appunto, che le appare come in sogno per aiutarla a esprimere l’indicibile.
Giovedi, 12/10/2023 - Antje Rávik Strubel è autrice e traduttrice tedesca originaria di Potsdam, che nel 2021 ha scritto Donna blu (Voland, traduzione di Cristina Vezzaro, 2023). Il romanzo racconta la violenza sessuale subita dalla protagonista Adina Schejbal, che dopo aver attraversato «tre confini fra quattro paesi europei» si ritrova a vivere in un appartamento di una palazzina a Helsinki, «un paese che non conosce, un paese del Nord, dove gli alberi sono diversi e la gente parla una lingua diversa, dove l’acqua ha un gusto diverso e l’orizzonte non ha colore». Nata e cresciuta ad Harrachov, nei pressi dei Monti dei Giganti, e figlia della Rivoluzione di Velluto che portò alla dissoluzione della Cecoslovacchia, Adina deve ora fare i conti con la difficoltà di raccontare il dolore in un mondo che sembra non prestarle ascolto. A correre in suo aiuto è una misteriosa figura, la donna blu, appunto, che le appare come in sogno per aiutarla a esprimere l’indicibile.
Rávik Strubel racconta la difficoltà delle donne di esprimersi in un mondo ancora governato dalla logica patriarcale. Questo sentire l’avvicina ai romanzi di Christa Wolf. La Wolf ‒ soprattutto nei romanzi Cassandra e Medea ‒ ha raccontato la difficoltà delle donne di affermare la propria voce in una società dominata da logiche di potere patriarcali. In questi due romanzi l’autrice tedesca la protagonista prende coscienza di sé passando per il passato rimosso e il dolore di una violenza. Cosa che si ritrova anche nella Donna blu, Adina non solo è una donna che ha subito una violenza, ma è ‘muta’ perché deve tradurre i suoi pensieri dal cieco in altre lingue ‒ come l’inglese, il russo o il tedesco ‒ che non padroneggia completamente.
Per sfuggire dal proprio trauma e per confrontarsi con esso, Adina si inventa un nuovo nome. Nella Germania dell’Est, ad esempio, diventa Nina, a Helsinki è Sala, e nelle chat online che frequenta si fa chiamare Mohicano, ispirandosi al libro L’ultimo dei Mohicani di James Fenimore Cooper. Il motivo per cui si fa chiamare in quest’ultimo modo permette di capire le vicende di Adina. Sceglie «Il Mohicano [perché] è l’ultimo e non ha una storia». Ma ha anche chiaro che cosa sia il flusso della Storia: «si pensa sempre che la storia sia qualcosa di vecchio, che si ha alle spalle, nel passato. Ma non è vero. È molto più complicato» di come lo si immagina. La madre e la nonna sono il passato. Eppure sono anche davanti a lei. La precedono. Ma chi procede dietro di lei non è anche ciò che l’attende? Insomma, il futuro?, si chiede la protagonista ad un certo punto.
Il suo dramma sta nelle parole. Che sembrano bersagliarla, soffocarla, costringerla al silenzio. Usare il nick name Mohicano, per Adina significa esprime l’incapacità di comunicare il proprio passato e la propria identità agli altri. Questa impossibilità è dovuta al cambio di lingua che ha vissuto sulla sua pelle. Se, per esempio, comunicare con Leonides, un europarlamentare estone che frequenta a Helsinki, l’inglese rende il tutto più oscuro, «le parole tedesche», invece, «non le ubbidivano. Anziché dire quello che voleva, diceva quel poco che riusciva a dire, che sembrava però seguire più la logica della lingua straniera che i suoi pensieri».
Se le parole la sovrastano e le provocano sofferenza, è Adina a creare un nuovo modo di esprimersi attraverso la consapevolezza che, quando si parla ciò che conta è sentirsi a proprio agio, servirsi della lingua, che aveva una logica diversa dalla sua.
È proprio nell’uso improprio delle lingue assimilate che Adina riesce a dare forma alle cicatrici del suo corpo e a esprimere l’insondabile. Gli errori commessi nell’uso di alcune parole o tempi verbali, ma anche l’impossibilità di esprimere certi concetti le permettono di far emergere la sofferenza attraverso le contraddizioni esistenziale in cui vive. È in questo modo che Adina riesce ad avvicinarsi al suo dolore, ed è attraverso i punti oscuri della comunicazione e del passaggio da una lingua all’altra.
La scrittura della Rávik Strubel risulta scarna; a livello narratologico, invece, il tempo narrato alterna continuamente passato a presente, realizzando quella che Miryam Schellbach ‒ critica di «Die Zeit» ‒ ha definito una ‘poetica della discrezione’, in cui all’avvicinarsi del trauma Adina ritorna coi pensieri al presente, per raccontare la difficoltà di confrontarsi con la sofferenza e la necessità, narrandolo, di allontanarlo da sé.
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®




Lascia un Commento