
Un' affascinante ipotesi: Gesù in India. Intervista a Manuel Olivares.
Il libro - molto ben documentato e affascinante - indaga gli anni perduti di Gesù (quelli di cui non si fa menzione nei Vangeli) che ne ridefiniscono la figura nei termini di un viaggiatore e profeta universale (p. 25).
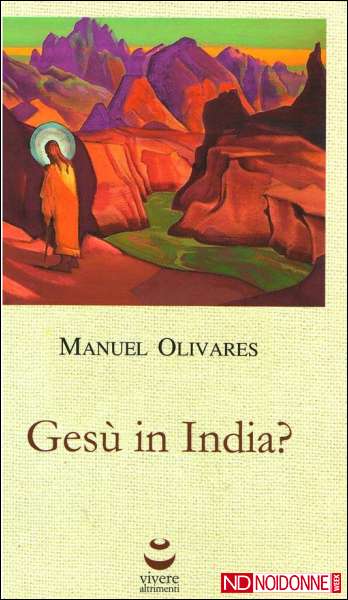 Giovedi, 04/02/2016 - Un’ affascinante ipotesi: sulle tracce di Gesù in India. Intervista a Manuel Olivares.
Giovedi, 04/02/2016 - Un’ affascinante ipotesi: sulle tracce di Gesù in India. Intervista a Manuel Olivares.Manuel Olivares, sociologo di formazione, vive e lavora tra Londra e l’Asia. Nel 2002 pubblica il saggio dal titolo Vegetariani come, dove, perché (Malatempora Ed) al quale seguono Comuni, comunità ed ecovillaggi in Italia (2003) e Comuni, comunità, ecovillaggi in Italia, in Europa, nel mondo (2007). Nel 2009 fonda l’editrice Viverealtrimenti, per esordire con Un giardino dell’Eden, il suo primo testo di fiction e Comuni, comunità, ecovillaggi su un antico e moderno movimento di comunità sperimentali ed ecosostenibili. Seguono Yoga based on authentic Indian traditions, il suo primo libro in inglese e Barboni sì ma in casa propria, una raccolta di racconti e poesie. Gesù in India? è maturato nel corso di dieci anni di studi e ricerche sul campo, prevalentemente in Kashmir, Punjab e Ladakh, avendo come base la città santa di Varanasi.
Il libro - molto ben documentato e affascinante - indaga gli “anni perduti” di Gesù (quelli di cui non si fa menzione nei Vangeli) che ne ridefiniscono la figura nei termini di un viaggiatore e profeta universale (p. 25). Pare che Gesù, partito dalla Palestina appena dodicenne, abbia compiuto un pellegrinaggio di di-ciassette anni in India, nel corso dei quali si aprì, da discepolo, agli insegnamenti del Buddha e, allo stesso tempo, predicò come un maestro (p. 26).
- La tua è una vita da nomade: si può tornare indietro da questa scelta?
Penso proprio di sì. Io amo molto la prospettiva filosofica buddhista che si basa su tre caposaldi: dukkha, anicca, anatta; (inevitabilità della) sofferenza, impermanenza e assenza di un sé autonomo perché tutto è interconnesso, ragion per cui, scriveva il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh: noi non, semplice-mente, siamo, bensì inter-siamo.
Per rispondere alla tua domanda, considererei il secondo caposaldo: l’impermanenza. Tutto è impermanente, transitorio, la parola “definitivo” ha sempre avuto, a mio vedere, un che di arbitrario, come dire, di falso. Dunque non posso che risponderti: oggi vivo nomade, consapevole che domani, se dovessi ancora esserci, potrei scegliere o essere costretto a vivere in altro modo. Dunque, certo, si può tornare indietro anche se, in realtà, indietro non si torna mai. La stessa, eventuale, sedentarizzazione sarebbe, difatti, un’esperienza diversa da quella vissuta in precedenza (io stesso sarei, nel frattempo, cambiato), da accogliere, possibilmente, con l’apertura che si dovrebbe a tutte le esperienze nuove, cercando di concedere il meno possibile alla paura. Noi tutti siamo nuovi ogni giorno. Nulla stagna, anche se così può sembrare.
Ti racconto un breve aneddoto di qualche anno fa. Sono in Thailandia, a Chiang Mai e ho appena terminato un ritiro in un importante monastero buddhista della città (Wat Ram Poeng), dove a suo tempo andò in visita anche Benedetto XVI. Il monaco che ha seguito noi stranieri nel corso della nostra permanenza (io, tra me, lo chiamavo Ho Chi Minh) ha un carattere strano, come dire, un po’ furastico.
Sono dunque appena “rientrato nel secolo” ma, nei giorni successivi, decido di fare un altro ritiro. Dunque torno in monastero, vado da Ho Chi Minh e gli chiedo se, di lì a una settimana, posso rientrare per altri dieci giorni. Lui mi dice di sì, che c’è posto. Nel corso della settimana che mi separa dal ritiro, tuttavia, decido di non farlo più. Colpevolmente non lo vado a dire a Ho Chi Minh anche se mi sono trasferito a vivere a due passi dal monastero e dovrei farlo con solerzia. Passano circa dieci giorni e giunge il momento in cui decido di passare in monastero per una breve seduta di meditazione, terminata la quale, avviandomi verso l’uscita (i monasteri buddhisti, in Thailandia ma anche altrove, non sono, in genere, costituiti da un solo edificio, sono più delle cittadelle con molti edifici: vari templi, foresterie, uffici) chi ti incontro? Ho Chi Minh. In principio mi prende un minimo di sgomento. Lui, ti dicevo, ha un carattere furastico e se mi avesse fatto una lavata di testa avrebbe avuto perfettamente ragione. Mi vede ma non mi saluta (va specificato che non salutarsi, in Oriente, è molto più normale che in Occidente, il saluto in quelle terre non è così scontato, nel caso dei monaci, poi, dovrebbero essere i laici a salutare per primi). Io decido rapidamente di non fare finta di niente, di avvicinarmi e scusarmi. Dunque, dopo averlo salutato rispettosamente, gli faccio: mi dispiace per non essere venuto ad avvertire che non avrei fatto un nuovo ritiro, spero di non aver tenuto occupato il posto per qualcun altro. Ho avuto degli impedimenti...ma Ho Chi Minh mi ha già interrotto con un ampio sorriso: don’t worry, mi risponde con tono distaccato, everything is impermanent!
Io dalle letture buddhiste avevo già in qualche modo assimilato il concetto ma debbo dire che quell’episodio con Ho Chi Minh lo ha proprio impresso a fuoco nella mia coscienza.
È come se avesse rappresentato un piccolo satori, una piccola illuminazione. Certo, tutto è impermanente! Limitiamoci a ricordare questo.
-Che significato ha una vita nomade? Quello della libertà o anche quello dell’egoismo?
Lo stesso concetto di ego, da un punto di vista buddhista, è arbitrario. Come ti dicevo prima, citando Thich Nhat Hanh, noi non, semplicemente, siamo, bensì inter-siamo. Ho appena caricato sul canale You Tube della Viverealtrimenti una bella intervista a Mario Monicelli, noto solitario, persona che non si è mai fatta una famiglia dunque, secondo alcuni, egoista oltre che misogeno e misantropo (povero Monicelli, giele attribuivano tutte...). L’intervistatore gli chiede lumi sulla sua solitudine e lui da, a mio avviso, risposte che denotano una buona saggezza. Dice di non soffrirne perché, alla fine, sta solo unicamente in casa propria, dove la solitudine può essere godibile (stando in uno spazio protetto che, inoltre, è anche il proprio, albergando le proprie cose). “Quando esco nel mio quartiere”, dice Monicelli nell’intervista (il bel Rione Monti di Roma), “sono sempre in relazione: vado dal barbiere, vado a fare la spesa, conosco tutti e tutti mi vogliono bene, dunque non mi sento solo”. Credo avesse ragione, che fosse ben consapevole di inter-essere e che lo stesso concetto di solitudine sia frutto più di paura che di altro. In virtù della dimensione dell’interessenza, si può essere in contatto con gli altri anche senza dividere con loro spazi fisici. Si può essere in contatto, ad esempio, attraverso i sogni, soprattutto i cosiddetti sogni vividi dove probabilmente incontriamo anche forme di coscienza disincarnata, vive nel piano incorporeo (la coscienza non ha necessariamente bisogno di un corpo, di una “tunica di carne”, per utilizzare un antico concetto gnostico), di persone trapassate che non sono definitivamente scomparse, sono solo passate da un piano di realtà all’altro.
Dunque, a mio parere, dovremmo in primo luogo dotarci di categorie di riferimento più ampie e poi, alla luce di queste, riconsiderare alcuni concetti. Abbiamo parlato della solitudine, abbiamo accennato all’ego (con cui noi siamo identificati tutte le volte che dimentichiamo non solo di essere ma di inter-essere), consideriamo meglio il concetto di egoismo. È, come spesso accade, un concetto molto relativo. Mi è capitato di verificare quanto spesso si accusino, egoisticamente, gli altri di essere egoisti. Capita che li si consideri tali perché si nutrono, nei loro riguardi, delle aspettative che loro non soddisfano. L’epiteto di egoisti viene dunque dato loro, spesse volte e in certa misura, in ragione di una propria frustrazione però sarebbe anche saggio chiedersi: quanto sono egoista, io, a pretendere che un’altra persona soddisfi a pieno le mie aspettative? Fino a che punto è eticamente lecito, da parte mia, avere un certo genere di aspettative nei riguardi di un altro? Essere egoisti, a mio modo di vedere, è prima di tutto una questione di ignoranza. Più siamo coscienti di inter-essere, più il rapporto con l’altro è all’insegna di uno scambio naturale che ricorda le inspirazioni (con cui si prende l’ossigeno rilasciato dalle piante) e le espirazioni (con cui si rilascia anidride carbonica che viene utilizzata dalle piante nel corso della fotosintesi clorofilliana).
Dunque, per rispondere alla tua domanda in merito al senso egoistico di una vita nomade, non posso che dirti: dipende! Dipende da come la si vive. Il nomade non è un marziano, è una persona come tutte, può essere saggia o stolta, buona o cattiva, egoista o meno. Quante persone che hanno una famiglia regolare, avendo magari provveduto a sistemare i figli in una casa vicina alla propria, si comportano in modo egoistico? Certo, la qualità dei rapporti in una vita nomade è diversa da quella di persone stanziali. Non tutti riescono a tenere adeguatamente conto di quanto le persone possano essere legittimamente “biodiverse”, trovando più semplice giudicare in base a categorie stereotipe.
Veniamo ora alla libertà. Mi chiedi se il significato di una vita nomade possa essere quello della libertà.
Io mi domando e ti domando, a questo punto: cosa significa essere veramente liberi? Mi viene in mente un dialogo del film Easy Rider, cult degli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta. Lo ricordo praticamente a memoria. Jack Nicholson, avvocato alcoolizzato, si è appena aggregato a due beatniks capelloni, vagabondi, motociclisti, reietti e fumatori di ganja. La sera, di fronte a un bel fuoco di bivacco, uno dei due gli dice: “a noi non affittano le stanze negli hotel, nemmeno in quelli più economici perché le persone, di noi, hanno paura”. Jack Nicholson, a quel punto, uomo di mondo, integrato ed emarginato a un tempo, in grado dunque di dominare entrambe le prospettive, di coloro che sono inseriti nel sistema e degli outsiders, gli risponde in modo molto filosofico: “non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate. Voi rappresentate la libertà!”.
“Cosa c’è di male nella libertà”, gli risponde a quel punto il beatnik (Dennis Hopper), “la libertà è tutto...”.
“Oh, sì”, riprende Jack Nicholson, “la libertà è tutto ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose di-verse. Voglio dire: è difficile essere liberi quando ti vendono e ti comprano al mercato. Certo, ti parlano, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura!”.
Una paura, avrebbe ripreso Hopper, “che non li fa scappare” ma, avrebbe infine chiosato Nicholson, “li rende pericolosi”.
Difatti Dennis Hopper e Peter Fonda, i due beatniks, lasciato Jack Nicholson al suo destino e alla sua botti-glia, avrebbero fatto una brutta fine. La paura della loro libertà avrebbe reso, effettivamente, gli “integrati” pericolosi…in un paese, gli Stati Uniti, dove le armi sono sempre girate con una certa disinvoltura: Bang!
Dunque, cosa significa essere veramente liberi? Quanto figure come quelle di Dennis Hopper e Peter Fonda in Easy Rider rappresentano davvero la libertà? Io credo ne rappresentino, senz’altro, la ricerca spasmodica, quella stessa cui la maggior parte delle persone che si integrano senza obiezioni rinuncia, magari per paura, odiando coloro che invece la portano avanti.
Ma quanto la vera libertà si possa trovare attraverso la dromomania, la mania di muoversi da un posto all’altro, senza meta precisa, credo sia altra questione.
Anche in questo caso credo la piena libertà si possa trovare nel momento in cui si è liberi dall’ignoranza, ci si ricordi, in ogni istante, che la sofferenza è inevitabile ma può essere profondamente accettata in quanto tale, che nulla meriti attaccamento morboso perché tutto è impermanente, che noi ci illudiamo di avere uno statuto ontologico autonomo mentre, in realtà, viviamo in una dimensione di interessenza e che tutto quel che accade è espressione di un’intelligenza superiore e qui si lascia il piano puramente filosofico entrando in quello della connessione e della relazione con il divino.
Il significato di una vita nomade è quello della libertà? Mi sembra francamente una prospettiva un po’ schematica. La persona veramente libera può essere nomadica o stanziale, l’essere libera, a quel punto, è una variabile indipendente.
-Il viaggio per il viaggio può essere una forma di fuga?
Certamente sì, può esserlo. È essenziale la maturità con cui si viaggia e questa la si può, naturalmente, ac-quisire con il tempo, “nessuno nasce imparato”. A questo proposito credo meriti specificare una cosa. Il viaggio, di per sé, non rende edotti, genera sicuramente esperienza ma affinché l’esperienza si traduca in conoscenza e saggezza è necessario, il mondo, non solo calpestarlo. Va anche interpretato. In questo caso il viaggio diventa un elemento importante di un processo ermeneutico che possa contribuire a sviluppare conoscenza e saggezza. Insomma, si può anche girare tanto ma a vuoto, magari senza liberarsi delle quattro categorie stereotipe della propria cultura, relazionandosi con gli altri (esponenti di altre culture, anche profondamente diverse dalla propria) attraverso bieche proiezioni. Chi viaggia per fuggire rischia, a mio vedere, più di altri di girare a vuoto, per quanto il viaggio può sempre dare dei bandoli di consapevolezza in più e insegnare a continuare a viaggiare ma in maniera più matura.
-Certo il viaggio non è sempre quello romantico, esotico di cui parla Charles Baudelaire per esempio in “Invitation au voyage”: cosa si prova davanti alla miseria e alla povertà sapendo di non poter agire?
Bella domanda, grazie! Mi punge un po’ sul vivo perché io mi muovo fondamentalmente in Asia dove si trovano ancora molte forme di povertà e di miseria (e se la miseria materiale è orribile, è quasi ancora più orribile il fatto che generi altre forme, non immediatamente materiali, di miseria). Cosa si prova di fronte ad esse? Banale dire: rabbia e compassione ma, per quanto mi riguarda, provo soprattutto queste due emozioni.
Altrettanto banale parlare del grande senso di impotenza che ogni tanto coglie ma è proprio quello che in alcuni casi si prova. Poi, al solito, a costo di diventare noioso, la stessa percezione di questi fenomeni varia con il tempo. Ci si matura dentro, si tenta almeno di farlo, ci si cresce dentro. Si cerca di farsene una ragio-ne. Sicuramente la precarietà materiale e la sofferenza che genera tanto più colpisce quanto più coinvolge persone con le quali si creano rapporti umani che, con l’andare del tempo, acquisiscono spessore.
Un modo sicuramente bello per crescere dentro a quest’esperienza è sviluppare, con giusto equilibrio, la qualità che in sanscrito si chiama dana: generosità. Relazionarsi con persone che soffrono a causa di una precarietà materiale deve, a mio vedere, stimolare la consapevolezza del nostro privilegio e ispirare gesti di autentica generosità. Un privilegio che non viene, almeno in parte, condiviso è, a mio parere, immeritato.
Una bella frase di Salvador Allende è: “Noi vivremo in eterno in quella parte di noi che abbiamo donato agli altri!”. Vivere in Asia aiuta a farne tesoro.
-Dici che l’India è una “grande palestra di vita” e una “vera scuola di sopravvivenza”: che intendi?
Dalla tua domanda desumo che tu non sia mai stata in India...un paese che, a mio vedere, ti forma molto anche in ragione di quello che non ha oltre che di quello che ha. In India acquisisce veramente grande pre-gnanza il detto chi fa da sé fa per tre!
Gli indiani, persone molto spesso di straordinaria intelligenza e maturità umana, vivono non di rado in una sorta di torpore millenario, dettato da un deliberato immobilismo sociale (che oggi sta iniziando a venir meno; il paese è oramai nell’orbita americana, vista anche la necessità, a mio vedere piuttosto urgente, di contenere l’espansione e l’ascesa cinese; questo naturalmente ha i suoi pro e i suoi contro).
Dunque, sostanzialmente, su di loro non si può fare molto affidamento e per tirarsi fuori da tutti i guai in cui ti caccia il paese, dove ancora oggi manca, quasi ovunque, un’erogazione costante di energia elettrica, le connessioni internet sono ancora erratiche, gli standards igienici…aiuto e potrei continuare a lungo, bisogna davvero fare appello a tutte le proprie risorse (e, praticamente, solo a quelle) per viverci periodi ragionevolmente lunghi.
Dunque vivere in India finisce per essere un’esperienza davvero formativa in cui ci si scopre ogni giorno più o meno capaci di affrontare, praticamente in solitudine, le più svariate, grottesche e imprevedibili difficoltà, tra cui la costante guerra psicologica che è una delle caratteristiche antropologiche del paese.
-La lettura del tuo recente libro sulla permanenza di Gesù in India scorre piacevolmente grazie alla formula scelta, cioè quella d’intervallare pagine di diario a parti più teoriche e permette al lettore di entrare nelle abitudini di un mondo così lontano: ti capita mai di guardare al passato e di rimpiangere la scelta che hai fatto?
Amo molto la canzone, di Edith Piaf, Je ne regrette rien! Credo sia un approccio esistenziale giusto. Sul passato non c’è modo di intervenire, ristagnarci toglie invece l’opportunità di agire sulle due dimensioni temporali per le quali abbiamo facoltà di intervento: il presente e il futuro. Cerco di non avere rimpianti e di sorvolare su quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Per colpa mia o di altri, lascia il tempo che trova.
Credo sia importante avere sempre coscienza del fatto che l’essere umano è, fondamentalmente, una grande opera incompiuta. Inutile affannarsi a realizzare chissà cosa, dimenticando la nostra condizione di fragilità creaturale, di stare “come d’Autunno, sugli alberi, le foglie”. Facciamo un esempio personale: io ho scritto, fino ad oggi, dieci libri. In particolare i libri sulle comunità intenzionali e gli ecovillaggi hanno aiutato alcune persone a “vivere altrimenti”. Mi capita di ricevere per email o anche di persona manifestazioni di riconoscenza per questo. Spero che anche il mio ultimo libro, Gesù in India?, possa essere utile a chi lo legge e credo possa, almeno, aiutare a vedere il mondo anche con altri occhi e questo credo sia già una buona cosa. Ho dato un mio piccolo contributo alla collettività ma, se non tenessi a freno il desiderio, potrei volere fare di più e di più, potrei giudicarmi per non aver fatto ancora abbastanza ma di questo passo si finirebbe per rischiare di sviluppare quello che il sociologo francese dell’Ottocento, Emile Durkheim, chiamava appetito d’infinito. In realtà, l’infinito è la dimensione stessa della vita e la cosa ci dovrebbe tranquillizzare. Il mondo stesso, nell’ambito del quale, pur senza rendercene adeguatamente conto, inter-siamo, è conoscibile all’infinito perché non solo è immensamente grande ma cambia di momento in momento, trasmuta costantemente in qualcosa di simile ma, in ultima analisi, diverso da sé. Dunque non avremo mai modo di coglierlo nella sua infinità, anche se riuscissimo a girarlo e a viverlo tutto, dovremmo, a fine viaggio, iniziare da capo per trovare un mondo nuovo, solo “parente” del precedente. E il nostro mondo, lo sappiamo, è un fenomeno insignificante rispetto all’universo o agli universi, dove probabilmente molte altre civiltà, chissà di quante, infinite cose noi non sappiamo assolutamente nulla. Poi ci sono, come si accennava prima, le forme di coscienza disincarnata, tutto l’universo incorporeo e tutto è ordinato, pensato o chissà quale verbo sarebbe più appropriato usare, da un’intelligenza superiore, rispetto alla quale qualunque cosa noi si possa fare non può non perdere drammaticamente di valore.
A fronte di tutto questo, che importanza può avere se Manuel Olivares ha scritto dieci libri o venti o nessu-no? C’è una dimensione etica per cui, nel grande respiro del cosmo ognuno deve compiere il suo pur piccolo respiro ma, detto questo, le proiezioni egoiche, le ambizioni, le velleità e gli stessi rimpianti, se si cerca di essere costantemente coscienti del nostro inter-essere nell’infinito, nell’ambito di un ordine/ espressione di un’intelligenza sovrumana, diventano delle assolute inezie con le quali si dovrebbe evitare, nella misura del possibile, di perdere tempo. Qualunque cosa possa fare un uomo, solo con enormi difficoltà giungerà al “compimento della grande opera” (l’unico obiettivo che meriti davvero i nostri sforzi), per ascendere, secondo molte prospettive, a dimensioni di coscienza superiori, pur non scevre, a loro volta, da limiti.
Il parametro di riferimento, dunque, non deve essere tanto l’umano (e questo è invece uno dei problemi più gravi dell’Occidente contemporaneo e della suo narcisista società secolarizzata) ma, come a mio modo di vedere è ancora molto chiaro nel mondo islamico, il divino (l’intelligenza sovrumana cui si accennava, per azzardare una definizione) cui, semplicemente, abbandonarsi. E i musulmani hanno una straordinaria parola araba con la quale ribadiscono, nel quotidiano, il loro rimettersi completamente nelle mani di Dio, ben consci della loro fragilità creaturale: inshallah; Se Dio vuole! La cosa straordinaria è che molti di loro tendono a utilizzarla anche in relazione alle cose più banali, ad esempio: domani vado a fare una passeggiata, inshallah! Ed è un utilizzo che ha una pregnanza del tutto logica, oltre che mistica. In effetti: domani faccio una passeggiata innanzitutto se domani ci sono ancora; potrei morire nel sonno o potrebbe morire una persona a me vicina e domani dovrei andare nella camera ardente, non a passeggiare, potrebbe morire il gatto e questo potrebbe farmi passare la voglia di farla o potrebbe, semplicemente, piovere o potrei avere mal di testa o voglia di stare a letto con la mia ragazza perché il giorno prima abbiamo mangiato piccante e siamo pieni di fregole...quanto controllo abbiamo, effettivamente, non dico sulle nostre vite, anche sui loro banali dettagli? E allora perché non riappropriarci del nostro senso di fragilità creaturale, lasciando da parte la spocchia “un po’ francese” che abbiamo iniziato a metter su a partire dal secolo dei lumi e rioccupare il nostro posticino di piccole-grandi opere incompiute? Ecco, potremmo profondere energia in questo più che cedere alla tentazione di ristagnare nei rimpianti, in qualunque rimpianto.
-Tu sei abituato a viaggiare: il pellegrinaggio sulle tracce di Gesù in India cosa ha rappresentato per te rispetto agli altri viaggi?
È stato un viaggio straordinario perché per trovare i bandoli dei presunti anni indiani ho dovuto un minimo approfondire alcune scuole di pensiero in ambito hindu, buddhista e musulmano, andando, come si suol dire, sul campo.
L’India è un paese molto affascinante e inesauribile, sto trovando nuovi bandoli per cui la ricerca, come del resto scrivo alla conclusione del testo, è appena iniziata e la prospettiva è quella di un ritorno e di nuovi so-pralluoghi (“inshallah”). Considerando il viaggio già fatto, mi è successo di dovermi muovere anche fuori da rotte peculiarmente turistiche e naturalmente sono state le esperienze più pregnanti. Il Ladakh, conosciuto anche come Piccolo Tibet, è abbastanza sfruttato turisticamente. È stato il primo posto che ho visitato perché nel monastero ladakho di Hemis sono stati trovati dei manoscritti che hanno rappresentato il leitmotiv di molta ricerca sugli anni indiani di Gesù. Tuttavia, andare proprio a Hemis è stata un’esperienza molto profonda perché non essendoci andato da turista e dunque non dovendomi limitare a una visita di un pomeriggio, ho passato più di una notte in casa di una famiglia ladakha, nel villaggio poco distante dal monastero. In alternativa c’era solo la guesthouse del monastero, non mi risulta ci fossero alberghi, il posto ha un turismo da corriera, da tempi contingentati e fotografie frettolose.
Il Ladakh è davvero un posto da ascesi, cos’altro si può fare in un luogo dove persino l’ossigeno scarseggia? Ecco, per certi versi seguire i presunti itinerari di Gesù mi ha costretto a seguire percorsi di ascesi e questo non ha potuto non costituire la conferma che mettersi sulle tracce dei grandi uomini è sempre di grande beneficio. Una prima esperienza, in questo senso, la ebbi a Rishikesh nel 2006, nell’ashram di Shivananda, yogi con cui aveva studiato il grande storico delle religioni Mircea Eliade. Poi avrei scoperto che nei tempi in cui visse a Rishikesh Eliade, l’ashram ancora non esisteva e che lui aveva piuttosto vissuto in dei kuteers (grotte/capanne per asceti) dalla parte opposta del Gange, dunque quella volta non indovinai il posto ma ricordo fu un’esperienza straordinaria passare una settimana nell’ashram di un grande maestro spirituale e non in un comune albergo. Gli altri ospiti erano quasi tutti degli Swami o dei Sadhu. Mangiavamo in terra, con le mani, seduti su strisce di tela grezza, ci servivamo il té da un’enorme damigiana di ferro…era la dimensione ascetica vera e la stavo vivendo perché stavo tentando di emulare il grande maestro Eliade. Sulle tracce di Gesù questo discorso ha acquisito, naturalmente, ancora maggiore pregnanza, mi sono trovato a Srinagar, la prima volta nel 2009, quando la tensione nelle strade era più palpabile di oggi, con presidi di militari, sacchi di sabbia, mitraglie e fili spinati e poi ci sono tornato, nel 2014, dopo la splendida esperienza in Ladakh e ho visitato nuovamente Rozabal, il santuario dove sarebbe sepolto Gesù e dove tutti sconsigliano di andare perché la zona è particolarmente a rischio per la presenza di molti fondamentalisti kashmiri ma io non ho mai avuto percezione del pericolo e poi ero sulle tracce di un grande maestro e questo mi faceva sentire, in qualche modo, protetto. Poi ci fu l’incontro con la Comunità Islamica Ahmadiyya e un soggiorno nella loro città santa, Qadian, in Punjab. Un incontro da cui sono uscito profondamente cambiato, a seguito del quale ho iniziato a vedere il mondo anche con altri occhi perché, per quasi venti giorni, sono stato da solo in un contesto integralmente islamico che mi si è disvelato giorno dopo giorno e che ha iniziato a comunicarmi un’altra (la loro) versione della storia e dell’attualità ed ho iniziato ad avere glimpse, che poi avrei approfondito e sto continuando ad approfondire, di quella che credo possa essere definita, con una generica metafora, l’altra metà del cielo. Non più guscio di stereotipi: un grande mondo vero, di gente in carne e ossa che ha iniziato a prendere vita, vita vera intendo, non trailer televisivi o articoli di giornali, ad accogliermi e a parlarmi ed è stata la scoperta di un altro infinito da esplorare e tentare di capire, pur con tutta l’inadeguatezza dei mezzi di cui dispongo.
È stato veramente un grande viaggio, sulle tracce dei presunti anni indiani di Gesù e spero davvero che sia solo agli inizi...
-Che cosa ti affascina di Gesù? Come vedi la sua figura?
Mi fai una domanda difficile. È difficile parlare di una figura immensa come quella di Gesù. Proviamo. Intanto mi preme sottolineare che per me Gesù non è “della stessa sostanza del Padre”. Meglio: non l’ho mai sentito come tale (poi è questione di fede, per carità), l’ho sempre sentito come un grande maestro e, allo stesso tempo, ho sempre condiviso nel profondo la prospettiva che del personaggio da Fabrizio De André nel suo capolavoro La buona novella. In una parola, condivido la definizione di De André secondo cui Gesù sarebbe stato il più grande rivoluzionario della storia. Una grande scoperta è stata il posto di tutto rispetto che Gesù occupa nell’Islam, dove è soprattutto conosciuto con il nome arabo Issa. Ecco, oggi posso dirti che, in merito a Gesù e anche in merito alla visione di Dio (che si lega, del resto, a quella di Gesù), mi sento molto più vicino all’Islam che al Cristianesimo. Dio, nell’Islam, è il ganz Andere, il totalmente altro, imperscrutabile, cui ci si può solo accostare senza che sia pensabile alcuna fusione (come invece si propone nell’Induismo) perché non si può postulare una consustanzialità tra creatore e creato. Una prospettiva così trascendentalista del divino, che non può in nessun modo essere rappresentato (perché nel momento in cui lo si rappresenta, lo si limita), mi ha persuaso nel profondo. La non rappresentazione del divino credo, difatti, possa agevolare nell’intuizione o percezione...anche qui le parole non sono adeguate, dell’assoluto. Del non soluto, del non diluito, di ciò che è puro, non precipitato, in nessun modo, nel mondo delle forme. Pura intelligenza e pura potenza, di cui l’essere rappresenta un’espressione in assenza, tuttavia, è bene ripeterlo, di una qualunque consustanzialità. Dunque, in questa prospettiva, Dio non si può fare uomo. Non sarebbe più Dio, si “diluirebbe” nella condizione umana e gli stessi fedeli potrebbero finire per percepirlo, pur senza rendersene conto (parliamo in questo caso di elaborazioni inconsce di simboli), come, scusa l’espressione forte, “un dio decaduto”.
Un input di riflessione potrebbe essere il seguente: non può forse essere che la nascita di fenomeni come l’Umanesimo, propedeutici al Rinascimento prima e al Secolo dei lumi poi e, in una parola, alla progressiva collocazione dell’uomo e non più di Dio al centro del mondo occidentale, cristiano abbia le sue radici nella identificazione di Dio con un, pur grandioso, uomo? Senza nulla togliere al contributo che l’Umanesimo, il Rinascimento e l’Illuminismo hanno dato al progresso del genere umano, sono convinto fossero passaggi necessari, oggi ci troviamo con una cristianistà a brandelli e un mondo islamico che invece ha mantenuta integra, nel sociale e nella dimensione esistenziale della maggioranza dei suoi membri, la propria dimensione religiosa, che sta crescendo in fretta (secondo alcune stime l’Islam diventerà la prima religione al mondo entro il 2070) e ha già una presenza più che significativa in Europa e negli Stati Uniti.
Tutto questo, forse, anche perché l’Islam ha mantenuto al centro del proprio mondo Dio, ridimensionando costantemente l’uomo. Un Dio che, in virtù del proprio essere completamente trascendente, non si è mai “incarnato”.
Ciò non toglie che Gesù, nella prospettiva islamica (che io, come accennavo, tendo a condividere), pur non essendo Dio, ne sia stato guidato come il più grande profeta dopo Maometto: il protagonista del Sigillo della profezia.
Per quanto mi riguarda Gesù, oltre a essere stato un grande profeta, è anche stato, ripeto, il più grande rivoluzionario della storia, come sosteneva De André. Il suo grande impegno nel sociale è quanto mi coinvolge di più, la proposta di una visione intimamente fraterna, del relazionarsi con l’altro da uno spazio interiore di apertura, amore e non competizione. Il suo insegnamento è eterno e universale e credo sia del tutto auspicabile condividerlo con altre culture.
Grandi maestri indiani del Novecento e fondatori di nuovi movimenti religiosi si sono distinti nel sostenere alcune ipotesi sugli anni indiani di Gesù: autorità del calibro di Paramhansa Yogananda, Osho Rajneesh e Sai Baba, per citare solo i più conosciuti.
-Vi accomuna il viaggio?
Sicuramente la dimensione di vita nomadica che emerge da diverse letture apocrife della figura di Gesù e che riprende fedelmente lo stile di vita di Buddha e dei suoi discepoli la sento, per forza di cose, molto vicina.
-Nel libro si accenna al fatto che, secondo un testimone oculare, Gesù non morì sulla croce, ma fu deposto vivo, con le funzioni vitali sospese per poi tornare, dopo tre giorni allo stato psicofisico ordinario: non è strano? La crocifissione era una vera e propria condanna a morte, un’ordalia, non una tortura: in quanto, a Gesù, in aggiunta c’erano i chiodi che per i ladroni non erano presenti. Difficile sopravvivere.
Immagino sia difficile però ci sono testimonianze storiche, una ad esempio di Flavio Giuseppe, in cui si parla di persone crocifisse, pur con i chiodi e che, calate dalla croce, hanno avuto modo di sopravvivere. Poi, soprattutto, c’è il fenomeno di coloro che si fanno crocifiggere, a Pasqua, nelle Filippine. Con tanto di chiodi, in adempimento a un voto particolarmente impegnativo. Ce ne sono alcuni video su You tube. Rimangono in croce un’ora o due e poi ne vengono calati e, come scrive Jacopo Fo nel suo Gesù amava le donne e non era biondo, “naturalmente non muoiono”. Stando a quanto si legge sui vangeli canonici, Gesù è rimasto sulla croce massimo sei ore, un tempo considerato limitato per provocare la morte, al punto che il fatto che lui fosse morto, malgrado non gli avessero spezzato le gambe, ha lasciato scettici diversi contemporanei, a partire da Ponzio Pilato, come risulta dallo stesso Vangelo di Marco.
- Come definiresti the hearth of Asia, il cuore dell’Asia di cui parli nel libro?
In realtà l’espressione è ripresa dal titolo di un libro del pittore russo Nicholas Roerich che anche si mise sulle tracce degli anni indiani di Gesù, viaggiando in Asia per oltre quattro anni (dal 1923 al 1927). A me è venuta in mente, come avrai letto, quando sono stato a Srinagar la prima volta, mi sembrava davvero di stare nel cuore dell’Asia perché quella zona era uno snodo importante della celebre via della seta e, nel tempo, ha visto passare gente di ogni genere: mercanti dalla Cina, dalla Persia, dal Medio Oriente, dall’Asia Minore, dalla Grecia, dalla Palestina e dall’ Egitto e mercanti indiani diretti a Occidente o di ritorno in India. Mercanti ma anche, come scrive l’economista indiano, Premio Nobel, Amartya Sen, filosofi, cercatori del vero che, a loro volta, si muovevano lungo le stesse rotte.
Il Kashmir è stato per lungo tempo un luogo buddhista (il quarto concilio buddhista si è svolto a pochi chilometri da dove si trova attualmente Srinagar, intorno al 70 dopo Cristo), ha sempre ospitato importanti e colti lignaggi brahmanici (lo stesso Pandit Nehru era kashmiro), poi ha iniziato a islamizzarsi nel sedicesimo secolo con migrazioni di maestri sufi dalla Persia, credo davvero si presti ad essere definito the hearth of Asia.
-Il libro allude ad altre suggestive ipotesi, per esempio quella per cui Pilato sarebbe stato un “complice” di un disegno voluto a salvare Gesù.
Sì, sono ipotesi anche corroborate da alcuni documenti apocrifi, ad esempio la lettera di Pilato a Tiberio.
Naturalmente sono ipotesi di cui è difficile dimostrare la veridicità.
E ancora, quella secondo la quale la Sindone sarebbe una prova valida della sopravvivenza di Gesù alla crocifissione.
Sulla Sindone mi sono limitato a riportare quanto scrive Holger Kersten nel suo testo Jesus lived in India (tradotto in italiano con il titolo La vita di Gesù in India). È un filone di ricerca immenso e complesso quello relativo alla Sindone e io, al momento, non mi sento competente per esprimere un giudizio circostanziato.
- Si parla, nel libro, anche di origine ebraica di afghani e kashmiri.
Si, è un altro filone interessante di ricerca. Si ipotizza che almeno parte dei membri delle disperse dieci tribù di Israele si siano, nel tempo, stabilite in quei territori. Probabilmente a seguito di successive migrazioni, a partire dall’ottavo secolo Avanti Cristo, a seguito della diaspora assira e, con una certa consistenza, nel 175 avanti Cristo, probabilmente a fronte della durezza e intolleranza del regno ellenistico, in Palestina, di Antioco IV Epifane.
Come scrivo alla fine del libro, è auspicabile che questo e altri filoni di ricerca vengono seguiti anche da isti-tuzioni accademiche. Sarebbe buono, ad esempio, se venissero assegnate tesi di laurea su questi argomenti. Le ricerche, in una parola, debbono continuare e il drappello di ricercatori è auspicabile cresca e si diversifichi.
Fausta Genziana Le Piane
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®



Lascia un Commento