
Poeta simbolista dell’essenza
Marina Cvetaeva - “io ho abituato la mia anima a vivere fuori dalla finestra, io per tutta la vita mi specchiavo in essa…”
Cristina Carpinelli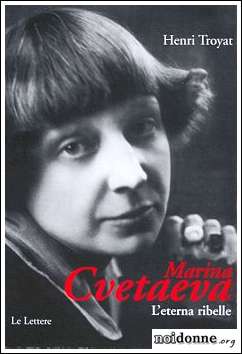 Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2008
Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2008
Scrivere un articolo su Marina Cvetaeva non è facile, poiché ciò non significa solo interrogarsi attorno ad una delle massime espressioni poetiche e letterarie della cultura europea del Novecento, ma esaminare nel contempo una figura femminile complessa, contraddittoria, spesso insopportabile a sé e agli altri, provata dalle pesanti vicissitudini che la vita le ha serbato. Una figura, pertanto, difficile, ambivalente, spesso sfuggente. Da alcuni descritta come “una dannata femmina: uterina e dunque isterica, frenetica, avida, stridula”. Da altri come “la moscovita di talento, ma irrimediabilmente dissoluta”. Da altri ancora come “un essere fuori dal tempo e dallo spazio”. Afferma il critico letterario Zveteremich: “Le sue lettere (oggi tradotte in tutto il mondo, e anche in Italia) ci rivelano un caratterino in cui la presunzione di sé e la volontà di prevaricazione erano preminenti”.
Persona esigente, cosciente della propria inestimabilità ed eccezionalità, arrogante e timida insieme (“arroganza e timidezza: sorelle consanguinee” - scrive lei stessa), è ciononostante ricordata per la sua intelligenza analitica, chiara, per la sua memoria precisa, per la sua ferrea logica. Caratteristiche queste che si riflettono nei suoi versi, tanto da definire la sua una poesia totalmente razionale e intellettuale, tra le meno romantiche che ci sia dato conoscere nel panorama non solo russo, ma generalmente europeo e americano. Paradossalmente, l’intuizione e il sentire, sono per lei elementi essenziali per cogliere il senso delle cose: “L’indagine logica è indispensabile, ma è pur sempre procedimento supplementare per comprendere il mondo” (M.C.). L’eco di una lirica straordinariamente spontanea, eppure animata da un ossessivo controllo razionale, s’inserisce nel contesto di un linguaggio poetico che vuole essere innovatore, il più possibile funzionale al servizio che deve prestare, e quindi “esatto, economico, privo d’attributi superflui”. La poesia della Cvetaeva non è al servizio della melodia, del canto, bensì della trasmissione dell’essenza delle cose: “Il fine della creazione non è allietare il lettore con begli echi delle parole” (M.C.). Il ruolo determinante del suono, del fonema, nella sua opera non significa affatto concessione al canto, alla melodia: “Io non penso, io ascolto. Poi cerco un’incarnazione esatta nella parola” (M.C.). La Cvetaeva, con Majakovskij, è definita “poeta anticanto, colui che costruisce il verso non sull’estetica della melodia”.
In realtà, dietro la freddezza della sua poesia rispetto alla retorica della patria perduta o al culto delle sue tradizioni, si cela un temperamento tutt’altro che indifferente: inquieto, frenetico, volutamente anarchico, che sempre la spinge allo sbaraglio, d’una vitalità pagana, ribelle e blasfema, sempre pronta ad andare contro corrente. Afferma lo storico Mirskij: “L’anarchismo della sua arte si esprime sia nella straordinaria libertà e varietà delle forme e dei procedimenti, sia nella sua profonda indifferenza verso il canone e il gusto”. Inoltre, nulla d’umano le è estraneo e questa concreta umanità è in lei molto forte, acuta. Più di una volta la poetessa sottolinea che si occupa della vita, non della letteratura. La letteratura dietro la quale non si sente la vita, la natura, viene da lei definita con disprezzo “belles lettres”.
Tuttavia, nel mondo della creatività della Cvetaeva, la “vita come essa è” non ha spazio, perché è “un luogo dove non si può vivere”. E’ da lei, addirittura, fatto proprio il principio espresso nell’aforisma del poeta russo Tredjakovskij, secondo cui “il poeta è una persona che crea e, nell’invenzione poetica, egli rappresenta la realtà per come potrebbe o dovrebbe essere”. In verità, dietro quest’aforisma citato dai critici per comprendere il segreto creativo della poesia della Cvetaeva, si nasconde anche il rifiuto di una dimensione terrena da lei stessa definita “umiliante”. E non avrebbe potuto essere altrimenti se solo ci si sofferma ad analizzare il suo vissuto. La critica Anna Saakijantz ha di recente affermato: “La Cvetaeva era una creatura di grande energia e questa energia le bastava oltre che per la sua opera, per la difficile vita quotidiana, nel senso più terreno, materiale. Noi conosciamo la vita di molti poeti, compositori, artisti in difficoltà finanziarie, ma mai abbiamo trovato nella storia della letteratura condizioni di vita simili a quelle in cui ha vissuto Marina Cvetaeva”. E se alle difficoltà concrete, aggiungiamo la sua condizione d’emigrata, sofferta come esilio morale dalla Russia, le sue tragedie personali e familiari, ecco che possiamo capire perché lei si senta “straccio sbattuto dal vento della vita”. Marina Cvetaeva preferisce la comunicazione ultraterrena: “Il mio modo preferito di comunicare è ultraterreno: il sogno - vedere in sogno”, poiché il sogno è una delle possibili vie d’uscita dal mondo della vita reale, immagine archetipica di un mondo altro, non materiale, dove vivono e comunicano tra loro le anime. Dice l’esperta di letteratura russa Pessina Longo: “Tratto marcatamente cvetaeviano è (…) l’opposizione fra l’ideale da cui trae ispirazione - un ideale onirico - e la realtà vera, crudele, impietosa che è quella del suo vivere quotidiano”. La realtà àncora alla terra, alla casa, alla famiglia, ma la Cvetaeva non accetta la realtà perché le è ostile e perché non le permette di “vivere fuori dalla finestra”: “Io ho abituato la mia anima a vivere fuori dalla finestra, io per tutta la vita mi specchiavo in essa - oh! solo in essa - non la lasciavo penetrare in casa, così come non si prende in casa il cane randagio o l’uccello esotico. Ho fatto della mia anima la mia casa, ma mai la casa sarà la mia anima. Non ci sono nella mia vita, non sono a casa. L’anima in casa - a casa - per me è impensabile, proprio non ha senso”.
Nelle riflessioni della Cvetaeva, anima e natura si fondono e confondono, divenendo spesso termini intercambiabili: “Oltre la natura, cioè oltre l’anima, e oltre l’anima, cioè la natura, nulla mi commuove” (M.C.). Profondamente sensibile alle parole di Zukovskij: “Il romanticismo è l’anima”, la poetessa esalta quest’ultima che nel mondo circostante le pare avvilita, offesa, disarmata. “Marina è assolutamente eccezionale, sorprendente, peculiare. Ma vive fuori della vita quotidiana e fuori della logica, vive in un mondo proprio da lei creato”. Così afferma una memorialista. E anche Anastasija, sorella di Cvetaeva, ricorda come Marina è a tal punto convinta che il mondo sia governato dall’immaginazione da assumere un atteggiamento estremamente libero nei confronti della realtà: “Non tiene in conto la vita, ne costruisce una tutta sua”.
La Cvetaeva deve amare, perché l’amore è per un poeta unica fonte di vita. Ma l’amore a cui sovente ella tende, che si costruisce intorno, è “parvenza, fallace sentimento, e non ha nulla da dare alla donna. L’atto creativo, sollecitato da effimere pulsioni amorose, si eleva in raffigurazioni di straordinario lirismo per poi lasciare la donna svuotata, estenuata dalla sua stessa veemenza amorosa incapace di continuare il tragico gioco di una passione solo immaginata e di cui non conserva coscienza, perché nasce dall’Assenza” (Pessina Longo). Marina non ama la vita come tale, non l’ama perché è impossibile per lei entrare nel letto di Procuste delle imperfezioni terrestri, delle viltà dei giorni terrestri. Qui sta il grande paradosso cvetaeviano: la vera esperienza amorosa appartiene all’anima, alla poesia: “Tutta la mia vita è una storia d’amore con la mia anima” (M.C.). La terra le appare come il regno della ferialità e trivialità filistee, dominata dalla menzogna e dal tradimento, “mondo dei corpi” contrapposto al “mondo delle anime”. L’amore terreno è solo Eva (carne) che è in eterno conflitto con Psiche (anima): “Io non capisco Eva, che tutti amano. Io non capisco la carne come tale, non le riconosco alcun diritto - soprattutto quello alla voce, che io non ho mai udito” (M.C.). Pur senza negare gli attributi comuni dell’amore, la Cvetaeva li introduce nelle sue poesie, sforzandosi di spogliarli del loro involucro corporale, di liberarli dei ceppi della materia e della bassa sensibilità. La Cvetaeva ha molti amori nella sua vita, sentimentali, passionali, carnali, ma lei indubbiamente privilegia quelli cerebrali: per Pasternak, Rilke, Bachrach. Nella sua poesia, ella pone i suoi eroi in situazioni in cui gli amanti, separati, non possono incontrarsi fisicamente. Amori, tuttavia, che sono fragili e transitori, poiché il solo amore reale, durevole e sicuro è quello che Marina nutre per i suoi versi. Nella sua biografia tutto appare incerto e illusorio: le sue idee politiche, i giudizi critici, i drammi personali, tutto, tranne la sua poesia. La sua condizione di profuga acuisce maggiormente questo senso di precarietà che avvolge costantemente la sua vita. La stessa fine della poetessa è emblematica. Ha interrotto la sua vita quando si è resa conto che non aveva più senso continuare a vivere. Con un presentimento, ella sapeva di tornare in patria a morire: “Quando sono salita sulla tolda della nave per Elabuga (misera località dell’allora Repubblica tartara - n.d.a.) ho compreso che tutto era finito”. Sa che là non avrebbe potuto né vivere, né scrivere. Le ultime parole da lei indirizzate al Soviet del Fondo letterario, pochi giorni prima del suicidio, sono terribili: “Al Soviet del Fondo letterario. Prego di darmi un lavoro di sguattera nella mensa che sta per aprirsi. M. Cvetaeva”.
Marina Ivanovna Cvetaeva
Nata a Mosca nel 1892, figlia di un filologo e storico dell’arte e di una pianista di talento, muore suicida ad Elabuga (Tatarstan) nel 1941. A sette anni scrive già poesie e a diciotto sono pubblicati i suoi primi versi. Nel 1912 sposa S. Efron, da cui ha tre figli. Durante l'inverno 1919-20, in piena guerra civile, è costretta a lasciare la figlia, Irina, in un orfanotrofio, dove la bambina muore per denutrizione. Emigra nel 1922 (Berlino, Praga, Parigi) e ritorna in Russia nel 1939. Nell’agosto del 1939, sua figlia Alja viene arrestata e deportata in un gulag. Ancora prima era stata presa la sorella. In seguito è arrestato e fucilato il marito. Durante l’invasione tedesca, la Cvetaeva è evacuata ad Elabuga, dove, insieme con il figlio Mur, vive momenti di disperazione e di miseria inimmaginabili. La domenica del 31 agosto 1941, rimasta sola in casa, la Cvetaeva sale su una sedia, rigira una corda attorno ad una trave e s’impicca. Nessuno andrà ai suoi funerali. Il suo corpo è sepolto in una fossa comune.
(23 settembre 2008)
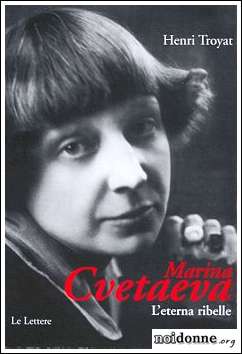 Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2008
Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2008Scrivere un articolo su Marina Cvetaeva non è facile, poiché ciò non significa solo interrogarsi attorno ad una delle massime espressioni poetiche e letterarie della cultura europea del Novecento, ma esaminare nel contempo una figura femminile complessa, contraddittoria, spesso insopportabile a sé e agli altri, provata dalle pesanti vicissitudini che la vita le ha serbato. Una figura, pertanto, difficile, ambivalente, spesso sfuggente. Da alcuni descritta come “una dannata femmina: uterina e dunque isterica, frenetica, avida, stridula”. Da altri come “la moscovita di talento, ma irrimediabilmente dissoluta”. Da altri ancora come “un essere fuori dal tempo e dallo spazio”. Afferma il critico letterario Zveteremich: “Le sue lettere (oggi tradotte in tutto il mondo, e anche in Italia) ci rivelano un caratterino in cui la presunzione di sé e la volontà di prevaricazione erano preminenti”.
Persona esigente, cosciente della propria inestimabilità ed eccezionalità, arrogante e timida insieme (“arroganza e timidezza: sorelle consanguinee” - scrive lei stessa), è ciononostante ricordata per la sua intelligenza analitica, chiara, per la sua memoria precisa, per la sua ferrea logica. Caratteristiche queste che si riflettono nei suoi versi, tanto da definire la sua una poesia totalmente razionale e intellettuale, tra le meno romantiche che ci sia dato conoscere nel panorama non solo russo, ma generalmente europeo e americano. Paradossalmente, l’intuizione e il sentire, sono per lei elementi essenziali per cogliere il senso delle cose: “L’indagine logica è indispensabile, ma è pur sempre procedimento supplementare per comprendere il mondo” (M.C.). L’eco di una lirica straordinariamente spontanea, eppure animata da un ossessivo controllo razionale, s’inserisce nel contesto di un linguaggio poetico che vuole essere innovatore, il più possibile funzionale al servizio che deve prestare, e quindi “esatto, economico, privo d’attributi superflui”. La poesia della Cvetaeva non è al servizio della melodia, del canto, bensì della trasmissione dell’essenza delle cose: “Il fine della creazione non è allietare il lettore con begli echi delle parole” (M.C.). Il ruolo determinante del suono, del fonema, nella sua opera non significa affatto concessione al canto, alla melodia: “Io non penso, io ascolto. Poi cerco un’incarnazione esatta nella parola” (M.C.). La Cvetaeva, con Majakovskij, è definita “poeta anticanto, colui che costruisce il verso non sull’estetica della melodia”.
In realtà, dietro la freddezza della sua poesia rispetto alla retorica della patria perduta o al culto delle sue tradizioni, si cela un temperamento tutt’altro che indifferente: inquieto, frenetico, volutamente anarchico, che sempre la spinge allo sbaraglio, d’una vitalità pagana, ribelle e blasfema, sempre pronta ad andare contro corrente. Afferma lo storico Mirskij: “L’anarchismo della sua arte si esprime sia nella straordinaria libertà e varietà delle forme e dei procedimenti, sia nella sua profonda indifferenza verso il canone e il gusto”. Inoltre, nulla d’umano le è estraneo e questa concreta umanità è in lei molto forte, acuta. Più di una volta la poetessa sottolinea che si occupa della vita, non della letteratura. La letteratura dietro la quale non si sente la vita, la natura, viene da lei definita con disprezzo “belles lettres”.
Tuttavia, nel mondo della creatività della Cvetaeva, la “vita come essa è” non ha spazio, perché è “un luogo dove non si può vivere”. E’ da lei, addirittura, fatto proprio il principio espresso nell’aforisma del poeta russo Tredjakovskij, secondo cui “il poeta è una persona che crea e, nell’invenzione poetica, egli rappresenta la realtà per come potrebbe o dovrebbe essere”. In verità, dietro quest’aforisma citato dai critici per comprendere il segreto creativo della poesia della Cvetaeva, si nasconde anche il rifiuto di una dimensione terrena da lei stessa definita “umiliante”. E non avrebbe potuto essere altrimenti se solo ci si sofferma ad analizzare il suo vissuto. La critica Anna Saakijantz ha di recente affermato: “La Cvetaeva era una creatura di grande energia e questa energia le bastava oltre che per la sua opera, per la difficile vita quotidiana, nel senso più terreno, materiale. Noi conosciamo la vita di molti poeti, compositori, artisti in difficoltà finanziarie, ma mai abbiamo trovato nella storia della letteratura condizioni di vita simili a quelle in cui ha vissuto Marina Cvetaeva”. E se alle difficoltà concrete, aggiungiamo la sua condizione d’emigrata, sofferta come esilio morale dalla Russia, le sue tragedie personali e familiari, ecco che possiamo capire perché lei si senta “straccio sbattuto dal vento della vita”. Marina Cvetaeva preferisce la comunicazione ultraterrena: “Il mio modo preferito di comunicare è ultraterreno: il sogno - vedere in sogno”, poiché il sogno è una delle possibili vie d’uscita dal mondo della vita reale, immagine archetipica di un mondo altro, non materiale, dove vivono e comunicano tra loro le anime. Dice l’esperta di letteratura russa Pessina Longo: “Tratto marcatamente cvetaeviano è (…) l’opposizione fra l’ideale da cui trae ispirazione - un ideale onirico - e la realtà vera, crudele, impietosa che è quella del suo vivere quotidiano”. La realtà àncora alla terra, alla casa, alla famiglia, ma la Cvetaeva non accetta la realtà perché le è ostile e perché non le permette di “vivere fuori dalla finestra”: “Io ho abituato la mia anima a vivere fuori dalla finestra, io per tutta la vita mi specchiavo in essa - oh! solo in essa - non la lasciavo penetrare in casa, così come non si prende in casa il cane randagio o l’uccello esotico. Ho fatto della mia anima la mia casa, ma mai la casa sarà la mia anima. Non ci sono nella mia vita, non sono a casa. L’anima in casa - a casa - per me è impensabile, proprio non ha senso”.
Nelle riflessioni della Cvetaeva, anima e natura si fondono e confondono, divenendo spesso termini intercambiabili: “Oltre la natura, cioè oltre l’anima, e oltre l’anima, cioè la natura, nulla mi commuove” (M.C.). Profondamente sensibile alle parole di Zukovskij: “Il romanticismo è l’anima”, la poetessa esalta quest’ultima che nel mondo circostante le pare avvilita, offesa, disarmata. “Marina è assolutamente eccezionale, sorprendente, peculiare. Ma vive fuori della vita quotidiana e fuori della logica, vive in un mondo proprio da lei creato”. Così afferma una memorialista. E anche Anastasija, sorella di Cvetaeva, ricorda come Marina è a tal punto convinta che il mondo sia governato dall’immaginazione da assumere un atteggiamento estremamente libero nei confronti della realtà: “Non tiene in conto la vita, ne costruisce una tutta sua”.
La Cvetaeva deve amare, perché l’amore è per un poeta unica fonte di vita. Ma l’amore a cui sovente ella tende, che si costruisce intorno, è “parvenza, fallace sentimento, e non ha nulla da dare alla donna. L’atto creativo, sollecitato da effimere pulsioni amorose, si eleva in raffigurazioni di straordinario lirismo per poi lasciare la donna svuotata, estenuata dalla sua stessa veemenza amorosa incapace di continuare il tragico gioco di una passione solo immaginata e di cui non conserva coscienza, perché nasce dall’Assenza” (Pessina Longo). Marina non ama la vita come tale, non l’ama perché è impossibile per lei entrare nel letto di Procuste delle imperfezioni terrestri, delle viltà dei giorni terrestri. Qui sta il grande paradosso cvetaeviano: la vera esperienza amorosa appartiene all’anima, alla poesia: “Tutta la mia vita è una storia d’amore con la mia anima” (M.C.). La terra le appare come il regno della ferialità e trivialità filistee, dominata dalla menzogna e dal tradimento, “mondo dei corpi” contrapposto al “mondo delle anime”. L’amore terreno è solo Eva (carne) che è in eterno conflitto con Psiche (anima): “Io non capisco Eva, che tutti amano. Io non capisco la carne come tale, non le riconosco alcun diritto - soprattutto quello alla voce, che io non ho mai udito” (M.C.). Pur senza negare gli attributi comuni dell’amore, la Cvetaeva li introduce nelle sue poesie, sforzandosi di spogliarli del loro involucro corporale, di liberarli dei ceppi della materia e della bassa sensibilità. La Cvetaeva ha molti amori nella sua vita, sentimentali, passionali, carnali, ma lei indubbiamente privilegia quelli cerebrali: per Pasternak, Rilke, Bachrach. Nella sua poesia, ella pone i suoi eroi in situazioni in cui gli amanti, separati, non possono incontrarsi fisicamente. Amori, tuttavia, che sono fragili e transitori, poiché il solo amore reale, durevole e sicuro è quello che Marina nutre per i suoi versi. Nella sua biografia tutto appare incerto e illusorio: le sue idee politiche, i giudizi critici, i drammi personali, tutto, tranne la sua poesia. La sua condizione di profuga acuisce maggiormente questo senso di precarietà che avvolge costantemente la sua vita. La stessa fine della poetessa è emblematica. Ha interrotto la sua vita quando si è resa conto che non aveva più senso continuare a vivere. Con un presentimento, ella sapeva di tornare in patria a morire: “Quando sono salita sulla tolda della nave per Elabuga (misera località dell’allora Repubblica tartara - n.d.a.) ho compreso che tutto era finito”. Sa che là non avrebbe potuto né vivere, né scrivere. Le ultime parole da lei indirizzate al Soviet del Fondo letterario, pochi giorni prima del suicidio, sono terribili: “Al Soviet del Fondo letterario. Prego di darmi un lavoro di sguattera nella mensa che sta per aprirsi. M. Cvetaeva”.
Marina Ivanovna Cvetaeva
Nata a Mosca nel 1892, figlia di un filologo e storico dell’arte e di una pianista di talento, muore suicida ad Elabuga (Tatarstan) nel 1941. A sette anni scrive già poesie e a diciotto sono pubblicati i suoi primi versi. Nel 1912 sposa S. Efron, da cui ha tre figli. Durante l'inverno 1919-20, in piena guerra civile, è costretta a lasciare la figlia, Irina, in un orfanotrofio, dove la bambina muore per denutrizione. Emigra nel 1922 (Berlino, Praga, Parigi) e ritorna in Russia nel 1939. Nell’agosto del 1939, sua figlia Alja viene arrestata e deportata in un gulag. Ancora prima era stata presa la sorella. In seguito è arrestato e fucilato il marito. Durante l’invasione tedesca, la Cvetaeva è evacuata ad Elabuga, dove, insieme con il figlio Mur, vive momenti di disperazione e di miseria inimmaginabili. La domenica del 31 agosto 1941, rimasta sola in casa, la Cvetaeva sale su una sedia, rigira una corda attorno ad una trave e s’impicca. Nessuno andrà ai suoi funerali. Il suo corpo è sepolto in una fossa comune.
(23 settembre 2008)
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®




Lascia un Commento