
Il valore della complessità
Etica - Intervista a Luisella Battaglia
Bartolini Tiziana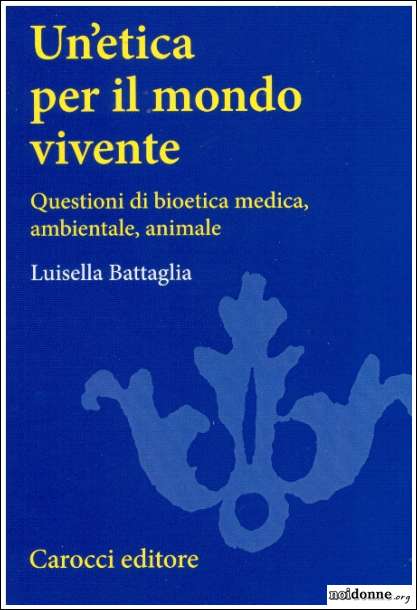 Martedi, 27/03/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2012
Martedi, 27/03/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2012
È uscito per Carocci l’ultimo libro di Luisella Battaglia - professore ordinario di Bioetica e Filosofia Morale presso l’Università di Genova e Suor Orsola Benincasa di Napoli, fondatrice dell’Istituto italiano di bioetica e membro del Comitato nazionale per la Bioetica - “Un’etica per il mondo vivente”, la cui tesi fondamentale è che l’etica deve riguardare tutto il mondo vivente, prendendo in esame e mettendo in relazione la bioetica medica, ambientale e animale.
Professoressa Battaglia, considerate le complessità dei temi che tratta la bioetica e i profondi disaccordi tra visioni e culture diverse, perché ritiene che le sue argomentazioni siano un contributo al dialogo?
In questi ultimi anni la bioetica si è prevalentemente occupata di temi riguardanti l’uomo - la sua nascita, la sua salute, la sua morte - trascurando, se non smarrendo, la grande novità della sua vocazione originaria: quella di essere un’etica relativa all’intero mondo vivente. L’ecologia è la scienza che ha restaurato la comunicazione tra uomo e natura facendoci scoprire la fragilità di quest’ultima e avvertire la nostra responsabilità di custodi della vita nel cosmo immenso. La rivoluzione copernicana ha cominciato a iscriversi nella nostra coscienza generando un duplice sentimento: di spaesamento (siamo su un pianeta secondario, in una galassia marginale) e di appartenenza (questa è la nostra terra, la nostra unica dimora). L’idea della comunità di destino terrestre ha costituito, come rileva Edgar Morin, l’evento chiave di fine millennio: occorre essere solidali con la Terra giacché la nostra vita è legata alla sua.
Egualmente, stiamo diventando sempre più consapevoli, grazie all’etologia, che l’uomo non può essere l’unico referente del discorso morale; si tratta, dunque, di andare oltre un’etica incentrata sulla persona umana, secondo il monito di Albert Schweitzer per il quale «un’etica che si occupa solo degli esseri umani è disumana». Dobbiamo pensare in termini planetari la politica, l’economia, la demografia, la salvaguardia di tesori biologici, ecologici e culturali regionali. La stessa nozione di qualità della vita andrebbe ridefinita in relazione a parametri più ampi che corrispondono agli interessi non solo dell’umanità attuale ma anche delle generazioni future, dell’ambiente e delle altre specie - i nuovi soggetti morali emergenti dalla bioetica.
Il suo libro è un invito ad affrontare l’etica e la scienza non attraverso una “nozione del limite” volta “rompere con l’avventura della modernità”, ma piuttosto lavorando su “un’etica della responsabilità” che può avere sviluppi fecondi attraverso una complessa dialettica tra “potere e ragione”. In che modo la bioetica può aprire nuove strade e come arriva ad ipotizzare un umanesimo ecologico?
Se vogliamo assegnare all’etica non un ruolo meramente negativo e disciplinatore, bensì creativo e dinamico, l’interrogativo cruciale riguarda non tanto i limiti da assegnare alle scienze, quanto le sfide cui essa è chiamata a rispondere. Per sfide possiamo intendere quel complesso di conoscenze, relative alla nostra natura, all’ambiente, alle altre specie che non possono non avere riflessi sulla nostra visione del mondo e, in genere, sul nostro modo di atteggiarci e la cui novità radicale rappresenta in ogni modo un problema ineludibile per la coscienza e la riflessione filosofica.
Accentuare unilateralmente gli elementi di pericolo connessi con il progresso tecnico-scientifico avrebbe un risultato paralizzante, nel senso di una logica proibizionistica e repressiva; d’altra parte, porre l’enfasi sugli aspetti positivi ed emancipatori del progresso scientifico, rischierebbe di accreditare l’antica illusione di matrice positivistica che il destino dell’uomo sia da esso infallibilmente garantito. Per questo, imboccare la strada di un’etica della responsabilità significa innanzitutto la riassunzione, da parte dell’uomo, del controllo razionale del suo incessante processo di progettazione. Le nostre responsabilità nascono dal nostro potere e ogni progresso della scienza e della tecnologia aumenta questo potere: sta a noi tenere presenti tutte le conseguenze volute e possibili del nostro agire attraverso uno sforzo anticipatorio di ragione e di immaginazione che includa la previsione degli effetti a lungo termine delle operazioni sull’uomo e sull’intero ecosistema.
Occorre, tuttavia, sgomberare il campo da un equivoco: quello di chi teme che la cura per l’ambiente e il rispetto per i non umani richiedano il sacrificio dei tradizionali obiettivi dell’etica umanistica: la giustizia, la libertà, il benessere, il progresso della conoscenza. In realtà, se pensiamo in termini di complessità e quindi riconosciamo la comunanza di destini tra uomo e natura, dobbiamo sforzarci di mettere in relazione le questioni relative all’ambiente e alla qualità della vita con quelle attinenti alla libertà e alla giustizia. La sfida è, dunque, di integrare i principi dell’etica umanistica con i nuovi doveri verso la natura e le altre specie progettando un nuovo umanesimo, un umanesimo ecologico capace di andare oltre le mura della città dell’uomo, nel riconoscimento di nuovi soggetti che appartengono anch’essi alla comunità di vita della terra.
Quali le difficoltà e i punti di forza di una bioetica laica?
Una prima difficoltà è costituita dal fatto che non esiste una sola bioetica laica: esiste una pluralità di riflessioni o, se si vuole, di famiglie filosofiche (deontologiche, utilitaristiche, giusnaturalistiche ecc.) accomunate, per indicare due principi generalissimi: l’opzione per la tolleranza, il principio – secondo una definizione di Norberto Bobbio - che dalla constatazione della molteplicità degli universi morali trae la conseguenza della necessità di una pacifica convivenza tra essi e il rifiuto del principio di autorità, in nome dell’appello alla ragione (ovvero, valgono gli argomenti per la forza intrinseca che essi possiedono, indipendentemente dall’autorità di chi li sostiene).
La bioetica laica potrebbe essere intesa come il tentativo di individuare quelle concezioni che possano essere giustificate di fronte a tutte le comunità morali, tradizioni e ideologie particolari. Fornendo un quadro neutrale per affrontare i problemi morali in campo biomedico, essa costituisce una soluzione pacifica, ad esempio, ai problemi dell’erogazione dell’assistenza sanitaria in una situazione in cui medici, infermieri, pazienti e individui sostengono in generale differenti visioni morali. Una morale comune dunque che, a differenza dei sistemi religiosi che variano all’infinito, è caratterizzata da una tendenziale unità, giacché rappresenta un nucleo razionale su cui può realizzarsi l’accordo di tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle loro diverse opzioni politiche e religiose e che sappia tener conto - senza timori reverenziali - dei dati forniti dalle conoscenze scientifiche.
Ma qui nasce un’altra difficoltà. Non ci dobbiamo nascondere che a chi è abituato alle risposte sicure di un’etica religiosamente fondata, una bioetica laica potrebbe generare un sentimento di frustrazione, in quanto le risposte definitive non sono a portata di mano. E tuttavia quello che da alcuni è considerato un aspetto deludente della filosofia contemporanea, e cioè il suo rifiuto di fornire ricette infallibili, di offrire un sistema definitivo di verità, la liberazione dai dubbi e dai timori che assalgono l’uomo dinanzi alle «scelte tragiche» può ritenersi un punto di forza di una bioetica laica. Decisivo è infatti il riconoscimento della realtà della persona individuale e della sua capacità di decidere - che la rende in ultima analisi responsabile dell’atteggiamento che assumerà dinanzi alla vita.
È molto interessante la sua trattazione del concetto di vulnerabilità. Non le sembra che il mondo guardi ad altri ordini di valori?
In senso stretto e specifico, vulnerabilità si riferisce a una situazione di particolare debolezza e fragilità, quella di soggetti che per età, condizione ecc., necessitano di una protezione particolare. In senso lato e generale, riguarda la condizione stessa di precarietà di tutti i viventi, umani e non umani, che sono esposti, nell’arco della loro esistenza, al rischio di essere feriti, e sono quindi eminentemente vulnerabili. E su questo secondo significato, dalla forte valenza etica e antropologica, che merita concentrarsi per evidenziarne le forti implicazioni per il tema della cura. Si tratta di un principio che prescrive, a fondamento dell’etica, il rispetto, la cura e la protezione del prossimo e del vivente in generale, sulla base della constatazione della fragilità, della finitudine e della mortalità degli esseri. Finora la bioetica non ha preso in una considerazione sufficientemente seria le esperienze di vulnerabilità umane. Penso, ad esempio, alla condizione dei bambini, alle forme diverse di abuso cui sono sottoposti, alla mancanza di attenzione ai loro bisogni materiali, emotivi, spirituali, alle conseguenze dell’epidemia dell’AIDS in Africa che lascia dietro di sé milioni di orfani.
Si tratta di promuovere una nuova idea della cittadinanza, che vada oltre l’idea del “contratto tra eguali”, tra cittadini standard - che esclude o emargina le varie forme di dipendenza: anziani, bambini, disabili. Su quel contratto era, ed è fondata, la società liberale, una società che ha avuto grandi meriti - riconoscere i diritti dell’uomo, promuovere le libertà fondamentali, separare i poteri, difendere l’individualità - ma che oggi, dinanzi a nuove sfide (allungamento della vita, nuovi poteri indotti dalla medicina, problemi inediti posti dalle biotecnologie) richiede un’integrazione che includa finalmente il valore della cura. Da qui l’importanza del linguaggio della vulnerabilità che apre il discorso morale a una sensibilità rinnovata nei confronti di quella condizione che definisce così radicalmente la nostra vita umana ma che ci consente altresì di guardare direttamente a tutte le forme di fragilità, di debolezza, di suscettibilità al dolore, umane e non umane. In effetti, la vulnerabilità è una caratteristica propria di tutti i viventi, sensibili alla sofferenza, a qualunque specie appartengano. Riconoscere tale principio significa aderire a una visione della bioetica aperta alla considerazione globale di tutti i vulnerabili e disposta a prendersene cura per sostenerne le ragioni e difenderne i diritti.
Come possono, filosofia e bioetica, aiutarci a leggere più in profondità bisogni e diritti dei componenti della famiglia?
Le nuove tecnologie riproduttive hanno sottratto la maternità e la paternità al destino, facendo nascere possibilità di decisioni libere dove prima c’era soltanto la logica della natura. Estendendo la nostra autonomia oltre le frontiere dell’etica e del diritto tradizionali, rispondono a domande crescenti che provengono dalla società ma - è questo un loro limite intrinseco - non sanno e non possono interrogarsi sul significato delle domande loro rivolte. La razionalità tecnologica è infatti perfettamente in grado di commisurare i mezzi e i fini, di indicarci quali siano gli strumenti più idonei per il conseguimento di determinati obiettivi ma è incapace di riflettere sul valore e sul significato dei fini perseguiti, mentre la bioetica ci ricorda che è indispensabile comprendere il senso delle domande, riflettere sui presupposti in esse impliciti, sulle aspettative che vi si rivelano. Uno degli interrogativi più radicali da cui partire, in un’indagine che dia spazio agli aspetti non solo medico-biologici ma anche simbolici della procreazione, riguarda innanzitutto il desiderio del figlio a tutti i costi. Che cosa cela, e insieme che cosa rivela, tale desiderio? Che cosa c’è dietro questo forte bisogno di filiazione? Non si è forse finora sufficientemente riflettuto sul rischio che le nuove tecnologie riproduttive enfatizzino oltre misura gli aspetti biologici della parentalità, valorizzando l’importanza del legame genetico a scapito di quello sociale, affettivo e simbolico. Grazie alla tecnologia tende a consolidarsi un’idea chiusa di famiglia, legata al vincolo della segretezza. La famiglia che decide di servirsi delle nuove tecnologie riproduttive vive molto spesso questa esperienza, al di là dei suoi esiti, come segreto - da custodire gelosamente tra i coniugi (o i parenti più stretti) e il medico: la famiglia, dunque, come sistema chiuso che vive da sola l’esperienza drammatica della sterilità e il progetto del bimbo perfetto reso possibile dalla tecnologia. Il vissuto delle coppie che si sottopongono a interventi di fecondazione artificiale è ancora dominato dall’immaginario, vale a dire da una fantasia inconscia onnipotente che porta i richiedenti a sottovalutare difficoltà di percorso ed eventuali insuccessi. In ciò il desiderio degli aspiranti genitori collude con quello dei medici: nel primo caso si tratta di avere, nel secondo di fare un bambino a qualsiasi costo. Quali riflessi sul bimbo che nasce da tale esperienza di privatezza/separatezza? Potrebbe rafforzarsi l’idea del figlio come possesso geloso: un figlio costato così tanto, in termini di investimento psicologico, affettivo, ma anche economico, frutto di tante tensioni, attese, ma anche di tante frustrazioni e speranze deluse, rischia di divenire un bene al cui godimento aspirare, una sorta di “diritto” di ultima generazione. Il familismo in tal modo si perfeziona: grazie alla tecnologia, il diritto al figlio potrebbe infatti convertirsi nel diritto al figlio del sesso voluto e la diagnostica prenatale finire con il diventare complice della “medicina dei desideri”, alimentando il progetto del bimbo “su misura”.
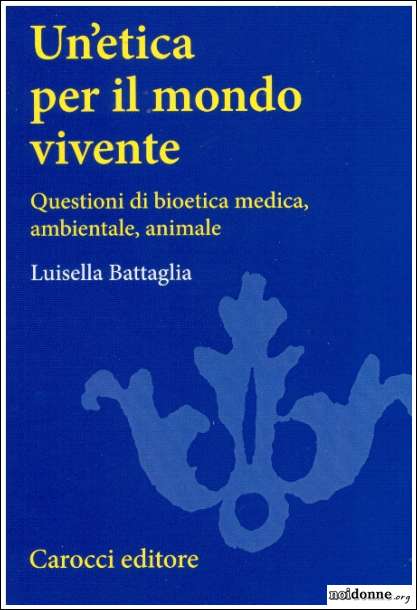 Martedi, 27/03/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2012
Martedi, 27/03/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2012È uscito per Carocci l’ultimo libro di Luisella Battaglia - professore ordinario di Bioetica e Filosofia Morale presso l’Università di Genova e Suor Orsola Benincasa di Napoli, fondatrice dell’Istituto italiano di bioetica e membro del Comitato nazionale per la Bioetica - “Un’etica per il mondo vivente”, la cui tesi fondamentale è che l’etica deve riguardare tutto il mondo vivente, prendendo in esame e mettendo in relazione la bioetica medica, ambientale e animale.
Professoressa Battaglia, considerate le complessità dei temi che tratta la bioetica e i profondi disaccordi tra visioni e culture diverse, perché ritiene che le sue argomentazioni siano un contributo al dialogo?
In questi ultimi anni la bioetica si è prevalentemente occupata di temi riguardanti l’uomo - la sua nascita, la sua salute, la sua morte - trascurando, se non smarrendo, la grande novità della sua vocazione originaria: quella di essere un’etica relativa all’intero mondo vivente. L’ecologia è la scienza che ha restaurato la comunicazione tra uomo e natura facendoci scoprire la fragilità di quest’ultima e avvertire la nostra responsabilità di custodi della vita nel cosmo immenso. La rivoluzione copernicana ha cominciato a iscriversi nella nostra coscienza generando un duplice sentimento: di spaesamento (siamo su un pianeta secondario, in una galassia marginale) e di appartenenza (questa è la nostra terra, la nostra unica dimora). L’idea della comunità di destino terrestre ha costituito, come rileva Edgar Morin, l’evento chiave di fine millennio: occorre essere solidali con la Terra giacché la nostra vita è legata alla sua.
Egualmente, stiamo diventando sempre più consapevoli, grazie all’etologia, che l’uomo non può essere l’unico referente del discorso morale; si tratta, dunque, di andare oltre un’etica incentrata sulla persona umana, secondo il monito di Albert Schweitzer per il quale «un’etica che si occupa solo degli esseri umani è disumana». Dobbiamo pensare in termini planetari la politica, l’economia, la demografia, la salvaguardia di tesori biologici, ecologici e culturali regionali. La stessa nozione di qualità della vita andrebbe ridefinita in relazione a parametri più ampi che corrispondono agli interessi non solo dell’umanità attuale ma anche delle generazioni future, dell’ambiente e delle altre specie - i nuovi soggetti morali emergenti dalla bioetica.
Il suo libro è un invito ad affrontare l’etica e la scienza non attraverso una “nozione del limite” volta “rompere con l’avventura della modernità”, ma piuttosto lavorando su “un’etica della responsabilità” che può avere sviluppi fecondi attraverso una complessa dialettica tra “potere e ragione”. In che modo la bioetica può aprire nuove strade e come arriva ad ipotizzare un umanesimo ecologico?
Se vogliamo assegnare all’etica non un ruolo meramente negativo e disciplinatore, bensì creativo e dinamico, l’interrogativo cruciale riguarda non tanto i limiti da assegnare alle scienze, quanto le sfide cui essa è chiamata a rispondere. Per sfide possiamo intendere quel complesso di conoscenze, relative alla nostra natura, all’ambiente, alle altre specie che non possono non avere riflessi sulla nostra visione del mondo e, in genere, sul nostro modo di atteggiarci e la cui novità radicale rappresenta in ogni modo un problema ineludibile per la coscienza e la riflessione filosofica.
Accentuare unilateralmente gli elementi di pericolo connessi con il progresso tecnico-scientifico avrebbe un risultato paralizzante, nel senso di una logica proibizionistica e repressiva; d’altra parte, porre l’enfasi sugli aspetti positivi ed emancipatori del progresso scientifico, rischierebbe di accreditare l’antica illusione di matrice positivistica che il destino dell’uomo sia da esso infallibilmente garantito. Per questo, imboccare la strada di un’etica della responsabilità significa innanzitutto la riassunzione, da parte dell’uomo, del controllo razionale del suo incessante processo di progettazione. Le nostre responsabilità nascono dal nostro potere e ogni progresso della scienza e della tecnologia aumenta questo potere: sta a noi tenere presenti tutte le conseguenze volute e possibili del nostro agire attraverso uno sforzo anticipatorio di ragione e di immaginazione che includa la previsione degli effetti a lungo termine delle operazioni sull’uomo e sull’intero ecosistema.
Occorre, tuttavia, sgomberare il campo da un equivoco: quello di chi teme che la cura per l’ambiente e il rispetto per i non umani richiedano il sacrificio dei tradizionali obiettivi dell’etica umanistica: la giustizia, la libertà, il benessere, il progresso della conoscenza. In realtà, se pensiamo in termini di complessità e quindi riconosciamo la comunanza di destini tra uomo e natura, dobbiamo sforzarci di mettere in relazione le questioni relative all’ambiente e alla qualità della vita con quelle attinenti alla libertà e alla giustizia. La sfida è, dunque, di integrare i principi dell’etica umanistica con i nuovi doveri verso la natura e le altre specie progettando un nuovo umanesimo, un umanesimo ecologico capace di andare oltre le mura della città dell’uomo, nel riconoscimento di nuovi soggetti che appartengono anch’essi alla comunità di vita della terra.
Quali le difficoltà e i punti di forza di una bioetica laica?
Una prima difficoltà è costituita dal fatto che non esiste una sola bioetica laica: esiste una pluralità di riflessioni o, se si vuole, di famiglie filosofiche (deontologiche, utilitaristiche, giusnaturalistiche ecc.) accomunate, per indicare due principi generalissimi: l’opzione per la tolleranza, il principio – secondo una definizione di Norberto Bobbio - che dalla constatazione della molteplicità degli universi morali trae la conseguenza della necessità di una pacifica convivenza tra essi e il rifiuto del principio di autorità, in nome dell’appello alla ragione (ovvero, valgono gli argomenti per la forza intrinseca che essi possiedono, indipendentemente dall’autorità di chi li sostiene).
La bioetica laica potrebbe essere intesa come il tentativo di individuare quelle concezioni che possano essere giustificate di fronte a tutte le comunità morali, tradizioni e ideologie particolari. Fornendo un quadro neutrale per affrontare i problemi morali in campo biomedico, essa costituisce una soluzione pacifica, ad esempio, ai problemi dell’erogazione dell’assistenza sanitaria in una situazione in cui medici, infermieri, pazienti e individui sostengono in generale differenti visioni morali. Una morale comune dunque che, a differenza dei sistemi religiosi che variano all’infinito, è caratterizzata da una tendenziale unità, giacché rappresenta un nucleo razionale su cui può realizzarsi l’accordo di tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle loro diverse opzioni politiche e religiose e che sappia tener conto - senza timori reverenziali - dei dati forniti dalle conoscenze scientifiche.
Ma qui nasce un’altra difficoltà. Non ci dobbiamo nascondere che a chi è abituato alle risposte sicure di un’etica religiosamente fondata, una bioetica laica potrebbe generare un sentimento di frustrazione, in quanto le risposte definitive non sono a portata di mano. E tuttavia quello che da alcuni è considerato un aspetto deludente della filosofia contemporanea, e cioè il suo rifiuto di fornire ricette infallibili, di offrire un sistema definitivo di verità, la liberazione dai dubbi e dai timori che assalgono l’uomo dinanzi alle «scelte tragiche» può ritenersi un punto di forza di una bioetica laica. Decisivo è infatti il riconoscimento della realtà della persona individuale e della sua capacità di decidere - che la rende in ultima analisi responsabile dell’atteggiamento che assumerà dinanzi alla vita.
È molto interessante la sua trattazione del concetto di vulnerabilità. Non le sembra che il mondo guardi ad altri ordini di valori?
In senso stretto e specifico, vulnerabilità si riferisce a una situazione di particolare debolezza e fragilità, quella di soggetti che per età, condizione ecc., necessitano di una protezione particolare. In senso lato e generale, riguarda la condizione stessa di precarietà di tutti i viventi, umani e non umani, che sono esposti, nell’arco della loro esistenza, al rischio di essere feriti, e sono quindi eminentemente vulnerabili. E su questo secondo significato, dalla forte valenza etica e antropologica, che merita concentrarsi per evidenziarne le forti implicazioni per il tema della cura. Si tratta di un principio che prescrive, a fondamento dell’etica, il rispetto, la cura e la protezione del prossimo e del vivente in generale, sulla base della constatazione della fragilità, della finitudine e della mortalità degli esseri. Finora la bioetica non ha preso in una considerazione sufficientemente seria le esperienze di vulnerabilità umane. Penso, ad esempio, alla condizione dei bambini, alle forme diverse di abuso cui sono sottoposti, alla mancanza di attenzione ai loro bisogni materiali, emotivi, spirituali, alle conseguenze dell’epidemia dell’AIDS in Africa che lascia dietro di sé milioni di orfani.
Si tratta di promuovere una nuova idea della cittadinanza, che vada oltre l’idea del “contratto tra eguali”, tra cittadini standard - che esclude o emargina le varie forme di dipendenza: anziani, bambini, disabili. Su quel contratto era, ed è fondata, la società liberale, una società che ha avuto grandi meriti - riconoscere i diritti dell’uomo, promuovere le libertà fondamentali, separare i poteri, difendere l’individualità - ma che oggi, dinanzi a nuove sfide (allungamento della vita, nuovi poteri indotti dalla medicina, problemi inediti posti dalle biotecnologie) richiede un’integrazione che includa finalmente il valore della cura. Da qui l’importanza del linguaggio della vulnerabilità che apre il discorso morale a una sensibilità rinnovata nei confronti di quella condizione che definisce così radicalmente la nostra vita umana ma che ci consente altresì di guardare direttamente a tutte le forme di fragilità, di debolezza, di suscettibilità al dolore, umane e non umane. In effetti, la vulnerabilità è una caratteristica propria di tutti i viventi, sensibili alla sofferenza, a qualunque specie appartengano. Riconoscere tale principio significa aderire a una visione della bioetica aperta alla considerazione globale di tutti i vulnerabili e disposta a prendersene cura per sostenerne le ragioni e difenderne i diritti.
Come possono, filosofia e bioetica, aiutarci a leggere più in profondità bisogni e diritti dei componenti della famiglia?
Le nuove tecnologie riproduttive hanno sottratto la maternità e la paternità al destino, facendo nascere possibilità di decisioni libere dove prima c’era soltanto la logica della natura. Estendendo la nostra autonomia oltre le frontiere dell’etica e del diritto tradizionali, rispondono a domande crescenti che provengono dalla società ma - è questo un loro limite intrinseco - non sanno e non possono interrogarsi sul significato delle domande loro rivolte. La razionalità tecnologica è infatti perfettamente in grado di commisurare i mezzi e i fini, di indicarci quali siano gli strumenti più idonei per il conseguimento di determinati obiettivi ma è incapace di riflettere sul valore e sul significato dei fini perseguiti, mentre la bioetica ci ricorda che è indispensabile comprendere il senso delle domande, riflettere sui presupposti in esse impliciti, sulle aspettative che vi si rivelano. Uno degli interrogativi più radicali da cui partire, in un’indagine che dia spazio agli aspetti non solo medico-biologici ma anche simbolici della procreazione, riguarda innanzitutto il desiderio del figlio a tutti i costi. Che cosa cela, e insieme che cosa rivela, tale desiderio? Che cosa c’è dietro questo forte bisogno di filiazione? Non si è forse finora sufficientemente riflettuto sul rischio che le nuove tecnologie riproduttive enfatizzino oltre misura gli aspetti biologici della parentalità, valorizzando l’importanza del legame genetico a scapito di quello sociale, affettivo e simbolico. Grazie alla tecnologia tende a consolidarsi un’idea chiusa di famiglia, legata al vincolo della segretezza. La famiglia che decide di servirsi delle nuove tecnologie riproduttive vive molto spesso questa esperienza, al di là dei suoi esiti, come segreto - da custodire gelosamente tra i coniugi (o i parenti più stretti) e il medico: la famiglia, dunque, come sistema chiuso che vive da sola l’esperienza drammatica della sterilità e il progetto del bimbo perfetto reso possibile dalla tecnologia. Il vissuto delle coppie che si sottopongono a interventi di fecondazione artificiale è ancora dominato dall’immaginario, vale a dire da una fantasia inconscia onnipotente che porta i richiedenti a sottovalutare difficoltà di percorso ed eventuali insuccessi. In ciò il desiderio degli aspiranti genitori collude con quello dei medici: nel primo caso si tratta di avere, nel secondo di fare un bambino a qualsiasi costo. Quali riflessi sul bimbo che nasce da tale esperienza di privatezza/separatezza? Potrebbe rafforzarsi l’idea del figlio come possesso geloso: un figlio costato così tanto, in termini di investimento psicologico, affettivo, ma anche economico, frutto di tante tensioni, attese, ma anche di tante frustrazioni e speranze deluse, rischia di divenire un bene al cui godimento aspirare, una sorta di “diritto” di ultima generazione. Il familismo in tal modo si perfeziona: grazie alla tecnologia, il diritto al figlio potrebbe infatti convertirsi nel diritto al figlio del sesso voluto e la diagnostica prenatale finire con il diventare complice della “medicina dei desideri”, alimentando il progetto del bimbo “su misura”.
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®




Lascia un Commento