
Capitale umano e Responsabilità Sociale d’Impresa
Parliamo di bioetica - Le imprese condividono con i singoli individui responsabilità relative al ben–essere sociale
Manti Franco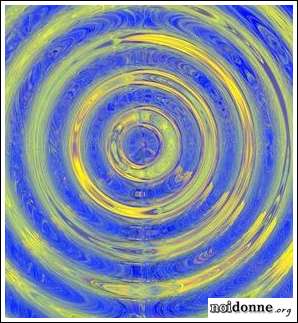 Giovedi, 28/10/2010 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2010
Giovedi, 28/10/2010 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2010
Franco Manti
Istituto Italiano di Bioetica
www.istitutobioetica.org
(1 novembre 2010)
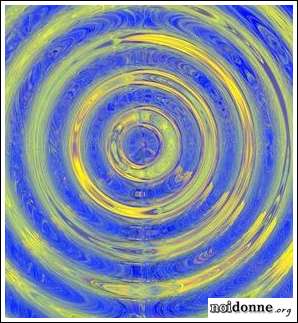 Giovedi, 28/10/2010 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2010
Giovedi, 28/10/2010 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2010Siamo soliti pensare l’impresa come una struttura organizzata, costituita da fattori quali capitale, lavoro, imprenditorialità, il cui scopo è, attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi, generare profitto per gli azionisti. La discussione sul “mercato etico”, iniziata negli U.S.A. già a partire dai primi anni cinquanta del novecento, ha aperto e continua ad aprire nuovi scenari nell’ambito degli studi etici ed economici, ma anche delle strategie e delle prassi aziendali. La tradizionale visione dell’impresa, che trova autorevole sostegno nel premio Nobel per l’economia Milton Friedman, secondo il quale l’unica responsabilità sociale di che la riguarda consiste nel produrre il maggior profitto possibile nel rispetto delle leggi vigenti, viene messa in discussione, altrettanto autorevolmente, da un altro premio Nobel per l’economia, Amartya Sen, che ritiene si debba saldare la frattura fra etica ed economia proprio in considerazione della natura sociale delle relazioni economiche. Le emergenze indotte dalla globalizzazione come la delocalizzazione delle aziende in Paesi del Terzo Mondo, le turbolenze e le crisi della finanza a livello internazionale, l’esigenza di coniugare libertà d’impresa e governance politica ed economica a livello planetario sembrano, sempre più, richiedere una valutazione etica delle strategie d’impresa. Tale valutazione, che pone al centro la relazione fra produttori e consumatori (passaggio dalla fidelizzazione alla fiducia), riguarda il rapporto fra impresa – territorio – società, la gestione della manodopera (in particolare nel Terzo Mondo) secondo criteri di giustizia ed equità, gli investimenti e il mercato finanziario, la trasparenza e la leggibilità dei bilanci, l’impatto ambientale, la qualità dei prodotti. Si è, così, da più parti, riconosciuta la rilevanza dell’”immagine morale” dell’impresa nella competizione economica e, in seguito, tale riconoscimento è stato esteso anche ad Associazioni, Enti, società no profit e cooperative fino ai servizi ormai aziendalizzati come il Servizio Sanitario Nazionale. In ambito pubblico, non meno che in quello privato si sono affermati criteri di sostenibilità, efficacia, efficienza, qualità, accountability (trasparenza nei resoconti) che richiedono una seria riflessione sulla relazione fra produttività, allocazione e gestione delle risorse (umane e finanziarie), equo risparmio, giustizia sociale.
Come ha evidenziato A. Sen, l’idealtipo dell’homo oeconomicus, votato al soddisfacimento egoistico dei propri interessi e la concezione dell’impresa volta esclusivamente al perseguimento del profitto che ne deriva, risultano, pertanto, sempre meno credibili (ciò vale tanto più per le aziende di servizi), mentre si avverte la necessità di coniugare criteri di efficienza e norme di autoregolazione che tengano presenti esigenze e bisogni di tutti i soggetti individuali, collettivi, istituzionali, interessati alla e dalla sua attività dell’impresa (stakeholder). Quest’ultima si connota, infatti, come un’istituzione sociale incidente sulla qualità della vita e sulle politiche territoriali e ambientali oltre, naturalmente, che su quelle economiche e sociali. Le imprese condividono, dunque, con i singoli individui responsabilità relative al ben–essere sociale. Se compito fondamentale dell’impresa è e rimane il perseguimento del successo economico, quando esso venga considerato come generatore di ben–essere sociale, non è affatto incompatibile con altre responsabilità a cominciare da quella sociale e, insieme, morale. In tal senso, assume rilievo non soltanto il successo, ma il processo attraverso il quale esso viene conseguito, la relazione fra risultati economici e modalità attraverso le quali essi sono realizzati e fruiti.
È alla luce di considerazioni come queste che si è affermata l’idea stessa di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o, in inglese, Corporate Social Responsibility (CSR). La letteratura nazionale e internazionale sulla RSI, ormai molto vasta, il susseguirsi di iniziative e convegni testimoniano l’interesse crescente sia da parte di studiosi che di imprenditori e manager. Ciò non toglie che la RSI, sia sul piano teorico che su quello delle pratiche concrete, sia esposta ad alcune rilevanti criticità. Intanto, la definizione di RSI è tutt’altro che univoca e diversi sono i modelli che vengono proposti e attuati. In termini generali, la RSI può essere definita come impegno volontario da parte delle imprese a rendere conto, attraverso pratiche appropriate, delle proprie decisioni e strategie a tutti i soggetti individuali, collettivi, istituzionali che possono essere interessati a o da effetti (positivi o negativi), indotti dalle loro attività.
Negli USA è prevalente un modello di tipo reputazionistico per cui le buone pratiche di RSI sono concepite come potenziamento della reputazione sociale dell’impresa. In Europa, la definizione standard è quella proposta dal Libro Verde della Commissione Europea, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, pubblicato nel 2001 dove la RSI si configura come “l’integrazione, su base volontaria, dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e relazioni con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” sul capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti”. Il Libro Verde non manca, poi, di sottolineare come le pratiche di RSI possano aumentare la competitività delle imprese. Quest’ultimo aspetto pone un nodo problematico: se la RSI viene considerata strumentalmente come una nuova strategia di marketing se ne depotenzia la “sostanza” etica. È per questo che, alcuni studiosi, ritengono vada distinta la responsabilità sociale da quella morale. La prima sarebbe indotta e condizionata dalle aspettative degli stakeholder, la seconda implicherebbe un impegno autonomo e attivo dell’impresa nella coniugazione fra obiettivi strategici e domande sociali. Certo è che, se il termine responsabilità viene inteso nel suo significato più ampio e profondo, le pratiche di RSI dovrebbero essere parti costitutive e fondamentali della mission (identità, compiti e obiettivi) dell’impresa.
Un altro aspetto oggetto di discussione è l’estensione della RSI al di là delle imprese profit, verso altri settori, in particolare aziende di servizio pubblico, enti locali, scuole. Per brevità, mi limito a evidenziare come la responsabilità sociale d’impresa, originariamente sia stata rivolta alle grandi realtà produttive (corporate) e come la sua estensione alla piccola e media impresa non possa essere considerata né semplice, né automatica. Si pensi ai costi che essa comporta, al fatto che eventuali riscontri positivi sono prevedibili soltanto a medio termine per comprendere come l’introduzione della RSI presso piccole e medie imprese ponga problemi non indifferenti di sostenibilità economica almeno nel breve periodo. È anche per queste ragioni che si fa strada l’idea di procedere attraverso forme di tipo associazionistico che consentano di suddividere e ammortizzare più facilmente i costi iniziali.
Infine, un altro punto critico riguarda gli “strumenti” di RSI. Se il codice etico viene concepito come un “fiore all’occhiello”, un espediente pubblicitario e non un documento effettivamente condiviso e radicato nella prassi comportamentale di tutti i soggetti interessati, la sua sussistenza diventa, obiettivamente, controproducente poiché rischierà di affermarsi una tendenza a non rispettarlo aggirandone le norme. Inoltre, anche quando vi sia condivisione formale, se il codice non viene “vissuto” non assolve a una funzione guida nella risoluzione di dilemmi etici si trasforma in un documento burocratico che nel tempo può perfino limitare creatività e innovazione. Discorso analogo vale per il bilancio sociale la cui funzione dovrebbe, davvero, essere quella di un rendiconto offerto alla società civile nel suo complesso, tale da consentire un giudizio sull’identità, gli obiettivi, il modo di agire dell’azienda alla luce della gestione economica complessiva e degli investimenti (in particolare nella destinazione di quote del valore aggiunto a scopi sociali). È di fondamentale importanza che il bilancio sociale sia collegato a quello d’esercizio. Diversamente, esso si ridurrebbe a uno strumento, forse pubblicitario, sicuramente autoreferenziale tradendo quella funzione di accountability che ne costituisce la ragion d’essere.
È alla luce di queste considerazioni che la prassi etica dell’impresa non può essere ridotta all’utilizzo, necessario, ma non sufficiente, di “strumenti” della RSI, ma deve essere orientata da una visione etica proattiva e generativa (a partire del management) che ponga al centro delle scelte strategiche la relazione con gli stakeholder. Si tratta di riflettere e avanzare proposte tali da rendere operativo quel passaggio dalla Corporate Social Responsibility alla Company Stakeholder Responsibility ( company sta per società, azienda, ditta) auspicato dal padre della teoria degli stakeholder R. E. Freeman. Si tratta di radicare l’attività di imprese e aziende, non solo delle grandi, appunto le corporation) su quattro livelli d’impegno: proposta base di valore (soddisfare, insieme, i diversi stakeholder); prolungata collaborazione fra gli stakeholder; comprensione di questioni sociali più ampie (basata sull’ idea di impresa come sistema aperto e inserito in un contesto sociale e politico da cui non può prescindere); leadership etica ( l’impegno morale come fonte di motivazione e ispirazione per l’innovazione). Perché ciò sia possibile è necessario che quanti, a diverso titolo, svolgono funzioni professionali presso aziende e imprese (siano esse pubbliche o private) vengano formati come soggetti eticamente competenti capaci, cioè, di comprendere l’effettiva portata di questioni e dilemmi morali che si possono porre nell’organizzazione e gestione delle attività, della produzione, dei servizi, dell’impatto sociale delle soluzioni adottate, capaci, anche, di avvalersi degli esiti di verifica e valutazione dei processi in atto nell’impresa e, quando necessario, del contributo specialistico di un consulente etico esterno.
La risoluzione della frattura determinatasi fra etica ed economia non è questione puramente accademica. Essa può essere ricomposta se l’approfondimento sul piano teorico è sostenuto e corroborato da buone pratiche. Una formazione continua all’etica d’impresa, oggi ancora poco praticata, soprattutto nel nostro Paese, ne è, per questo, una condizione fondamentale e imprescindibile.
Come ha evidenziato A. Sen, l’idealtipo dell’homo oeconomicus, votato al soddisfacimento egoistico dei propri interessi e la concezione dell’impresa volta esclusivamente al perseguimento del profitto che ne deriva, risultano, pertanto, sempre meno credibili (ciò vale tanto più per le aziende di servizi), mentre si avverte la necessità di coniugare criteri di efficienza e norme di autoregolazione che tengano presenti esigenze e bisogni di tutti i soggetti individuali, collettivi, istituzionali, interessati alla e dalla sua attività dell’impresa (stakeholder). Quest’ultima si connota, infatti, come un’istituzione sociale incidente sulla qualità della vita e sulle politiche territoriali e ambientali oltre, naturalmente, che su quelle economiche e sociali. Le imprese condividono, dunque, con i singoli individui responsabilità relative al ben–essere sociale. Se compito fondamentale dell’impresa è e rimane il perseguimento del successo economico, quando esso venga considerato come generatore di ben–essere sociale, non è affatto incompatibile con altre responsabilità a cominciare da quella sociale e, insieme, morale. In tal senso, assume rilievo non soltanto il successo, ma il processo attraverso il quale esso viene conseguito, la relazione fra risultati economici e modalità attraverso le quali essi sono realizzati e fruiti.
È alla luce di considerazioni come queste che si è affermata l’idea stessa di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o, in inglese, Corporate Social Responsibility (CSR). La letteratura nazionale e internazionale sulla RSI, ormai molto vasta, il susseguirsi di iniziative e convegni testimoniano l’interesse crescente sia da parte di studiosi che di imprenditori e manager. Ciò non toglie che la RSI, sia sul piano teorico che su quello delle pratiche concrete, sia esposta ad alcune rilevanti criticità. Intanto, la definizione di RSI è tutt’altro che univoca e diversi sono i modelli che vengono proposti e attuati. In termini generali, la RSI può essere definita come impegno volontario da parte delle imprese a rendere conto, attraverso pratiche appropriate, delle proprie decisioni e strategie a tutti i soggetti individuali, collettivi, istituzionali che possono essere interessati a o da effetti (positivi o negativi), indotti dalle loro attività.
Negli USA è prevalente un modello di tipo reputazionistico per cui le buone pratiche di RSI sono concepite come potenziamento della reputazione sociale dell’impresa. In Europa, la definizione standard è quella proposta dal Libro Verde della Commissione Europea, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, pubblicato nel 2001 dove la RSI si configura come “l’integrazione, su base volontaria, dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e relazioni con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” sul capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti”. Il Libro Verde non manca, poi, di sottolineare come le pratiche di RSI possano aumentare la competitività delle imprese. Quest’ultimo aspetto pone un nodo problematico: se la RSI viene considerata strumentalmente come una nuova strategia di marketing se ne depotenzia la “sostanza” etica. È per questo che, alcuni studiosi, ritengono vada distinta la responsabilità sociale da quella morale. La prima sarebbe indotta e condizionata dalle aspettative degli stakeholder, la seconda implicherebbe un impegno autonomo e attivo dell’impresa nella coniugazione fra obiettivi strategici e domande sociali. Certo è che, se il termine responsabilità viene inteso nel suo significato più ampio e profondo, le pratiche di RSI dovrebbero essere parti costitutive e fondamentali della mission (identità, compiti e obiettivi) dell’impresa.
Un altro aspetto oggetto di discussione è l’estensione della RSI al di là delle imprese profit, verso altri settori, in particolare aziende di servizio pubblico, enti locali, scuole. Per brevità, mi limito a evidenziare come la responsabilità sociale d’impresa, originariamente sia stata rivolta alle grandi realtà produttive (corporate) e come la sua estensione alla piccola e media impresa non possa essere considerata né semplice, né automatica. Si pensi ai costi che essa comporta, al fatto che eventuali riscontri positivi sono prevedibili soltanto a medio termine per comprendere come l’introduzione della RSI presso piccole e medie imprese ponga problemi non indifferenti di sostenibilità economica almeno nel breve periodo. È anche per queste ragioni che si fa strada l’idea di procedere attraverso forme di tipo associazionistico che consentano di suddividere e ammortizzare più facilmente i costi iniziali.
Infine, un altro punto critico riguarda gli “strumenti” di RSI. Se il codice etico viene concepito come un “fiore all’occhiello”, un espediente pubblicitario e non un documento effettivamente condiviso e radicato nella prassi comportamentale di tutti i soggetti interessati, la sua sussistenza diventa, obiettivamente, controproducente poiché rischierà di affermarsi una tendenza a non rispettarlo aggirandone le norme. Inoltre, anche quando vi sia condivisione formale, se il codice non viene “vissuto” non assolve a una funzione guida nella risoluzione di dilemmi etici si trasforma in un documento burocratico che nel tempo può perfino limitare creatività e innovazione. Discorso analogo vale per il bilancio sociale la cui funzione dovrebbe, davvero, essere quella di un rendiconto offerto alla società civile nel suo complesso, tale da consentire un giudizio sull’identità, gli obiettivi, il modo di agire dell’azienda alla luce della gestione economica complessiva e degli investimenti (in particolare nella destinazione di quote del valore aggiunto a scopi sociali). È di fondamentale importanza che il bilancio sociale sia collegato a quello d’esercizio. Diversamente, esso si ridurrebbe a uno strumento, forse pubblicitario, sicuramente autoreferenziale tradendo quella funzione di accountability che ne costituisce la ragion d’essere.
È alla luce di queste considerazioni che la prassi etica dell’impresa non può essere ridotta all’utilizzo, necessario, ma non sufficiente, di “strumenti” della RSI, ma deve essere orientata da una visione etica proattiva e generativa (a partire del management) che ponga al centro delle scelte strategiche la relazione con gli stakeholder. Si tratta di riflettere e avanzare proposte tali da rendere operativo quel passaggio dalla Corporate Social Responsibility alla Company Stakeholder Responsibility ( company sta per società, azienda, ditta) auspicato dal padre della teoria degli stakeholder R. E. Freeman. Si tratta di radicare l’attività di imprese e aziende, non solo delle grandi, appunto le corporation) su quattro livelli d’impegno: proposta base di valore (soddisfare, insieme, i diversi stakeholder); prolungata collaborazione fra gli stakeholder; comprensione di questioni sociali più ampie (basata sull’ idea di impresa come sistema aperto e inserito in un contesto sociale e politico da cui non può prescindere); leadership etica ( l’impegno morale come fonte di motivazione e ispirazione per l’innovazione). Perché ciò sia possibile è necessario che quanti, a diverso titolo, svolgono funzioni professionali presso aziende e imprese (siano esse pubbliche o private) vengano formati come soggetti eticamente competenti capaci, cioè, di comprendere l’effettiva portata di questioni e dilemmi morali che si possono porre nell’organizzazione e gestione delle attività, della produzione, dei servizi, dell’impatto sociale delle soluzioni adottate, capaci, anche, di avvalersi degli esiti di verifica e valutazione dei processi in atto nell’impresa e, quando necessario, del contributo specialistico di un consulente etico esterno.
La risoluzione della frattura determinatasi fra etica ed economia non è questione puramente accademica. Essa può essere ricomposta se l’approfondimento sul piano teorico è sostenuto e corroborato da buone pratiche. Una formazione continua all’etica d’impresa, oggi ancora poco praticata, soprattutto nel nostro Paese, ne è, per questo, una condizione fondamentale e imprescindibile.
Franco Manti
Istituto Italiano di Bioetica
www.istitutobioetica.org
(1 novembre 2010)
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®




Lascia un Commento