
Accanimento terapeutico
Parliamo di ... - Occorre difendere il carattere irriducibilmente personale delle scelte che riguardano il proprio corpo
Maria Antonietta La Torre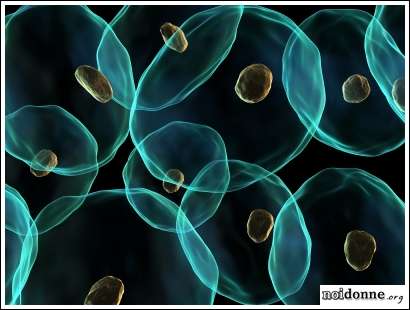 Lunedi, 18/04/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2011
Lunedi, 18/04/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2011
La disponibilità di tecniche mediche sempre più sofisticate, che consentono di mantenere in una condizione vitale individui che talvolta non sono più in condizione di esprimere la propria volontà, e quindi le proprie preferenze in merito alle cure alle quali vogliono essere sottoposti, ha riaperto il dibattito sull’accanimento terapeutico, poiché ci si trova talvolta su un punto-limite: non è sempre chiaro se si stia irragionevolmente procrastinando la morte o davvero prolungando l’esistenza. Ci si chiede, perciò, quali trattamenti siano effettivamente obbligatori e necessari, in vista del rispetto della dignità del morire e della volontà individuale.
A ben vedere, la stessa definizione di morte, in vista del prelievo di organi, è stata trasformata e sottoposta a una “decisione”, e ciò ha contribuito a rendere sempre meno naturale l’evento del morire. Si è stabilito che un individuo può essere considerato morto anche se il suo cuore batte ma vi è un silenzio conclamato dell’encefalo, mentre non molti decenni fa il battito cardiaco sarebbe stato considerato segno vitale: dunque in merito si è pervenuti a una convenzione medico-legale. E invece si fa sovente appello, in maniera quanto meno singolare, al rispetto di una “naturalità” del morire che, una volta sottratto al suo esito spontaneo grazie agli ausili tecnici, è di fatto artificiale.
Nonostante l’ampio consenso teorico sul rifiuto dell’accanimento terapeutico, perciò, vi è molta resistenza rispetto all’ipotesi di una regolamentazione delle direttive anticipate di trattamento, ossia dell’eventuale e volontaria (dunque mai obbligatoria, ma frutto di una libera scelta e sempre passibile di revoca) indicazione della propria volontà in merito ai trattamenti ai quali si desidererebbe essere o non essere sottoposti nel caso ci si trovasse nella condizione di non poter più esprimere la propria volontà. Il progresso biomedico riapre, allora, la riflessione su diritti, in effetti, già sanciti dalla nostra Costituzione, come il diritto a rifiutare le cure, esposti ora a nuove implicazioni. Per sottrarsi alle tentazioni paternalistiche che a volte il nostro legislatore manifesta, vuoi per pregiudizi ideologici, vuoi per inveterata tecno-fobia, sarebbe a mio avviso utile innanzitutto una difesa del carattere irriducibilmente personale delle scelte che riguardano il proprio corpo, specie di quelle che non coinvolgono altri che se stessi.
Conferire al legislatore il compito di definire in maniera autoritativa questioni complesse, ad esempio che cosa sia la vita, significa ostacolare un’attività legislativa che, in uno stato laico, dovrebbe essere rispettosa delle diverse visioni del mondo. Più utile mi sembra l’appello ad alcuni principi-guida, condivisibili con minor difficoltà, quale, per l’appunto, il principio di autodeterminazione, unanimemente accettato, peraltro, come fondamento del cosiddetto consenso informato. La Convenzione di Oviedo ha stabilito l’obbligatorietà di tale consenso prima di ogni intervento nel campo della salute e anche, sottolineando proprio il caso delle persone che non hanno o non hanno più la capacità di fornire un tale consenso, che si debba procedere a somministrare terapie soltanto se vi sia diretto beneficio. Occorrerebbe allora provare che le pratiche di prolungamento dell’esistenza in casi come quello di Eluana Englaro rientrino nella categoria del certo beneficio per quell’individuo: la tesi che, tenendo in vita artificialmente una persona che soffre o che non ha ragionevoli speranze di recuperare non semplicemente le sue funzioni vitali autonome, bensì la sua coscienza e un’accettabile qualità della vita, si faccia il suo bene è, a mio avviso, tutta da dimostrare.
Inoltre, mi pare insostenibile e contraddittorio che quando siamo nel pieno possesso delle nostre facoltà possiamo decidere per noi stessi anche fino alle estreme conseguenze, mentre in caso di perdita di queste facoltà il nostro corpo non sia più nella nostra disponibilità. La volontà della donna siciliana, che aveva consapevolmente rifiutato di operarsi per amputare un piede ormai in cancrena, è stata rispettata (in verità, i medici hanno provato a rivolgersi sia al comitato etico dell’ospedale che al tribunale, ma hanno poi dovuto arrendersi al principio che non si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio se il paziente lucidamente lo rifiuta) ed ella è stata lasciata morire. La perdita dell’autocoscienza comporterebbe, invece, lo spossessamento del proprio corpo e del proprio diritto. Ma fino a che punto è giusto imporre una terapia a un paziente senza più alcuna speranza di veder mutata la propria sorte? Il malato risulterebbe in tal modo prigioniero non solo della propria malattia, ma anche della volontà altrui. Il giudizio sulle condotte moralmente giuste, su ciò che è bene e male per il singolo, non può essere formulato a maggioranza o secondo ciò che ritiene il comune sentire, poiché riguarda scelte individuali che vanno rispettate anche se si discostano da quest’ultimo. I trattamenti che consentono di tenere in vita individui che solo qualche decennio fa sarebbero morti possono essere tramutati in obblighi? Se così fosse, verrebbe allora da domandarsi perché si sia negato che la disponibilità di tecniche avanzate per la fecondazione assistita configurasse un diritto a poterne usufruire, se non a condizioni assai limitate, e nel contempo si voglia sostenere che, viceversa, solo in casi estremi si possa non usufruire delle tecniche che agiscono nelle condizioni di terminalità.
Occorre, allora, tener fermi: 1. il principio di autodeterminazione individuale nelle scelte circa le cure mediche, da estendere anche alle situazioni in cui il soggetto non sia più in grado di effettuare autonomamente scelte consapevoli e 2. il vincolo sul piano etico e giuridico per il medico delle volontà espresse in anticipo dal soggetto, ferma restando la sua competenza nell’accertamento tecnico della situazione clinica ipotizzata nelle direttive. Il legislatore fallisce il proprio compito se pretende di imporre un’etica di stato, prevalente sulle scelte individuali, piuttosto che un insieme di criteri volti a disciplinare i comportamenti leciti, compatibilmente con la diversità delle visioni morali e valoriali.
Maria Antonietta La Torre
Istituto Italiano di Bioetica
www.istitutobioetica.org
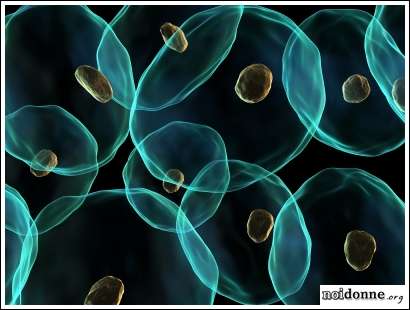 Lunedi, 18/04/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2011
Lunedi, 18/04/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2011La disponibilità di tecniche mediche sempre più sofisticate, che consentono di mantenere in una condizione vitale individui che talvolta non sono più in condizione di esprimere la propria volontà, e quindi le proprie preferenze in merito alle cure alle quali vogliono essere sottoposti, ha riaperto il dibattito sull’accanimento terapeutico, poiché ci si trova talvolta su un punto-limite: non è sempre chiaro se si stia irragionevolmente procrastinando la morte o davvero prolungando l’esistenza. Ci si chiede, perciò, quali trattamenti siano effettivamente obbligatori e necessari, in vista del rispetto della dignità del morire e della volontà individuale.
A ben vedere, la stessa definizione di morte, in vista del prelievo di organi, è stata trasformata e sottoposta a una “decisione”, e ciò ha contribuito a rendere sempre meno naturale l’evento del morire. Si è stabilito che un individuo può essere considerato morto anche se il suo cuore batte ma vi è un silenzio conclamato dell’encefalo, mentre non molti decenni fa il battito cardiaco sarebbe stato considerato segno vitale: dunque in merito si è pervenuti a una convenzione medico-legale. E invece si fa sovente appello, in maniera quanto meno singolare, al rispetto di una “naturalità” del morire che, una volta sottratto al suo esito spontaneo grazie agli ausili tecnici, è di fatto artificiale.
Nonostante l’ampio consenso teorico sul rifiuto dell’accanimento terapeutico, perciò, vi è molta resistenza rispetto all’ipotesi di una regolamentazione delle direttive anticipate di trattamento, ossia dell’eventuale e volontaria (dunque mai obbligatoria, ma frutto di una libera scelta e sempre passibile di revoca) indicazione della propria volontà in merito ai trattamenti ai quali si desidererebbe essere o non essere sottoposti nel caso ci si trovasse nella condizione di non poter più esprimere la propria volontà. Il progresso biomedico riapre, allora, la riflessione su diritti, in effetti, già sanciti dalla nostra Costituzione, come il diritto a rifiutare le cure, esposti ora a nuove implicazioni. Per sottrarsi alle tentazioni paternalistiche che a volte il nostro legislatore manifesta, vuoi per pregiudizi ideologici, vuoi per inveterata tecno-fobia, sarebbe a mio avviso utile innanzitutto una difesa del carattere irriducibilmente personale delle scelte che riguardano il proprio corpo, specie di quelle che non coinvolgono altri che se stessi.
Conferire al legislatore il compito di definire in maniera autoritativa questioni complesse, ad esempio che cosa sia la vita, significa ostacolare un’attività legislativa che, in uno stato laico, dovrebbe essere rispettosa delle diverse visioni del mondo. Più utile mi sembra l’appello ad alcuni principi-guida, condivisibili con minor difficoltà, quale, per l’appunto, il principio di autodeterminazione, unanimemente accettato, peraltro, come fondamento del cosiddetto consenso informato. La Convenzione di Oviedo ha stabilito l’obbligatorietà di tale consenso prima di ogni intervento nel campo della salute e anche, sottolineando proprio il caso delle persone che non hanno o non hanno più la capacità di fornire un tale consenso, che si debba procedere a somministrare terapie soltanto se vi sia diretto beneficio. Occorrerebbe allora provare che le pratiche di prolungamento dell’esistenza in casi come quello di Eluana Englaro rientrino nella categoria del certo beneficio per quell’individuo: la tesi che, tenendo in vita artificialmente una persona che soffre o che non ha ragionevoli speranze di recuperare non semplicemente le sue funzioni vitali autonome, bensì la sua coscienza e un’accettabile qualità della vita, si faccia il suo bene è, a mio avviso, tutta da dimostrare.
Inoltre, mi pare insostenibile e contraddittorio che quando siamo nel pieno possesso delle nostre facoltà possiamo decidere per noi stessi anche fino alle estreme conseguenze, mentre in caso di perdita di queste facoltà il nostro corpo non sia più nella nostra disponibilità. La volontà della donna siciliana, che aveva consapevolmente rifiutato di operarsi per amputare un piede ormai in cancrena, è stata rispettata (in verità, i medici hanno provato a rivolgersi sia al comitato etico dell’ospedale che al tribunale, ma hanno poi dovuto arrendersi al principio che non si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio se il paziente lucidamente lo rifiuta) ed ella è stata lasciata morire. La perdita dell’autocoscienza comporterebbe, invece, lo spossessamento del proprio corpo e del proprio diritto. Ma fino a che punto è giusto imporre una terapia a un paziente senza più alcuna speranza di veder mutata la propria sorte? Il malato risulterebbe in tal modo prigioniero non solo della propria malattia, ma anche della volontà altrui. Il giudizio sulle condotte moralmente giuste, su ciò che è bene e male per il singolo, non può essere formulato a maggioranza o secondo ciò che ritiene il comune sentire, poiché riguarda scelte individuali che vanno rispettate anche se si discostano da quest’ultimo. I trattamenti che consentono di tenere in vita individui che solo qualche decennio fa sarebbero morti possono essere tramutati in obblighi? Se così fosse, verrebbe allora da domandarsi perché si sia negato che la disponibilità di tecniche avanzate per la fecondazione assistita configurasse un diritto a poterne usufruire, se non a condizioni assai limitate, e nel contempo si voglia sostenere che, viceversa, solo in casi estremi si possa non usufruire delle tecniche che agiscono nelle condizioni di terminalità.
Occorre, allora, tener fermi: 1. il principio di autodeterminazione individuale nelle scelte circa le cure mediche, da estendere anche alle situazioni in cui il soggetto non sia più in grado di effettuare autonomamente scelte consapevoli e 2. il vincolo sul piano etico e giuridico per il medico delle volontà espresse in anticipo dal soggetto, ferma restando la sua competenza nell’accertamento tecnico della situazione clinica ipotizzata nelle direttive. Il legislatore fallisce il proprio compito se pretende di imporre un’etica di stato, prevalente sulle scelte individuali, piuttosto che un insieme di criteri volti a disciplinare i comportamenti leciti, compatibilmente con la diversità delle visioni morali e valoriali.
Maria Antonietta La Torre
Istituto Italiano di Bioetica
www.istitutobioetica.org
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®



Lascia un Commento