
Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta
Il nuovo libro di Stefania Prandi racconta la violenza maschile contro le donne attraverso le parole, i ricordi, il dolore e le speranze di chi resta e le ha amate davvero
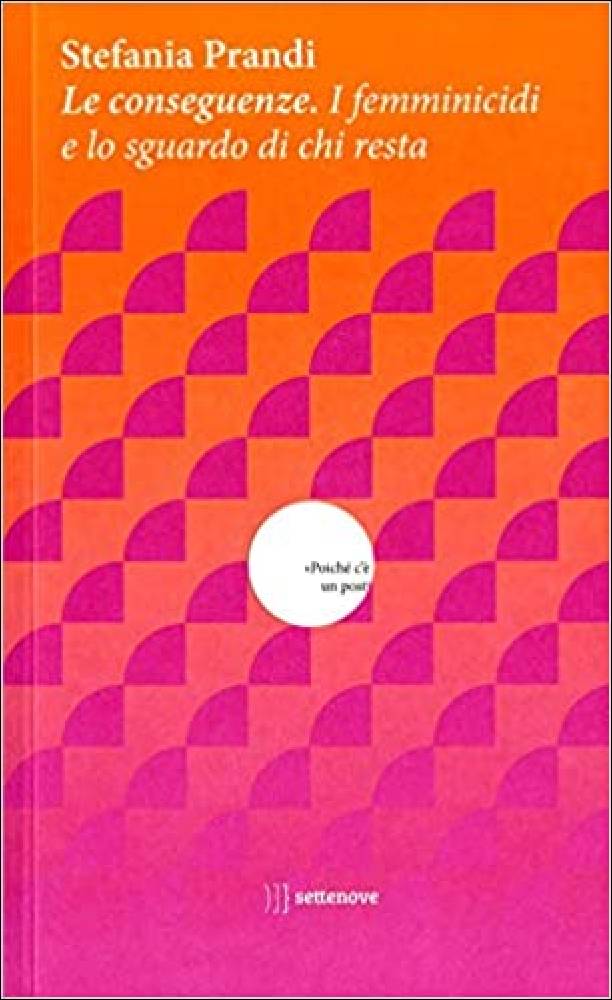 Domenica, 01/11/2020 - Stiamo guardando il telegiornale. Viene riportata in trenta secondi la notizia di una donna uccisa da suo marito o dal suo ex; ci viene detto che si è trattato di un raptus di gelosia o di una perdita di controllo dettata dal rifiuto della donna. E poi i trenta secondi finiscono e si passa ai risultati del campionato di calcio.
Domenica, 01/11/2020 - Stiamo guardando il telegiornale. Viene riportata in trenta secondi la notizia di una donna uccisa da suo marito o dal suo ex; ci viene detto che si è trattato di un raptus di gelosia o di una perdita di controllo dettata dal rifiuto della donna. E poi i trenta secondi finiscono e si passa ai risultati del campionato di calcio.Questa è la modalità di comunicazione che i media utilizzano per raccontare la violenza maschile contro le donne. Solo un nuovo nome di donna da aggiungere alla lista. Anzi a volte neanche quello, perché a volte le donne uccise nel nostro paese non hanno neanche la dignità di avere un nome. «Magari state pensando no, ho già abbastanza disgrazie: non ho voglia di ascoltare quelle degli altri» ha acutamente scritto Concita De Gregorio, commentando il libro di Stefania Prandi. Perché sì, la giornata è breve, gli impegni sono tanti, i problemi ce li abbiamo tutti, e allora perché dovremmo perdere tempo ad ascoltare quelli degli altri, ad intristirci per gli altri? Ebbene la risposta è che la morte di quella donna non riguarda solo lei, chi l’ha uccisa e chi avrà la sfortuna di sopravviverle, ma riguarda tutte e tutti noi, perché quella donna è stata uccisa da un uomo che è cresciuto nello stesso modo in cui siamo cresciute e cresciuti tutte/i noi, non è un uomo diverso dagli altri, malato o pazzo, è solo un uomo che ha ben appreso ciò che la società gli ha insegnato su cosa significa e deve significare essere donna ed essere uomo.
Ma la comunicazione mediatica preferisce il sensazionalismo, preferisce raccontare i particolari macabri, o la caccia all’assassino, o lo stupore dei vicini perché “sembravano tanto una bella coppia, non ci siamo mai accorti di niente”. Ma di quelle donne, delle vite di quelle donne, cosa resta dopo quei trenta secondi di telegiornale?
Ce lo racconta Stefania Prandi, giornalista e scrittrice, che all’esito di un lavoro di tre anni ha pubblicato il libro “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” (Ed. Settenove, 2020). Va detto innanzitutto che la casa editrice Settenove, nata nel 2013, è il primo progetto editoriale italiano interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. Affronta il tema da punti di vista differenti e attraverso tutti i generi letterari, con un’attenzione particolare alla narrativa per l'infanzia e l'adolescenza che contribuisce allo sviluppo di un immaginario libero da stereotipi. Eccezionali sono infatti i suoi libri di favole per bambine e bambini, a partire dal primo il cui titolo costituisce già il manifesto dell’editrice: “C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?” (di Raquel Diaz Reguera, 2013).
Stefania Prandi entra in punta di piedi nella vita di chi ha avuto la disgrazia di sopravvivere all’uccisione della propria figlia, sorella, madre, e ci racconta con toccante umanità cosa resta di quelle vite distrutte. «A loro restano i giorni del dopo, i ricordi immobili appesi ai muri, trattenuti dalle cornici, impressi nei vestiti impolverati, le spese legali, i ricorsi, le maldicenze nei tribunali («se l’è cercata», «era una poco di buono»), le giustificazioni («stavano litigando», «lui era fuori di sé per la gelosia», «era pazzo d’amore», «non accettava di essere lasciato»)». Ci racconta come queste madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli siano ignorate dalla stampa, dalla società, dallo Stato, di come siano condannate ad un ergastolo senza possibilità di sconti o permessi. Tra loro c’è chi scrive libri, chi organizza incontri nelle scuole, chi lancia petizioni, chi raccoglie fondi. «La reazione all’infinito dolore individuale, che da personale diventa politico, fatica a essere riconosciuta a livello istituzionale e mediatico. Eppure sono in molti a non smettere di combattere contro l’invisibilità e il silenzio, nemmeno a distanza di decenni dalla morte delle loro figlie, delle madri, delle sorelle. Il vero amore è questo, non quello degli uomini che le hanno uccise.»
Di questo parla il libro di Stefania: di amore. Di un amore vero, non di quello che la stampa e perfino i tribunali attribuiscono agli assassini. Il loro non è amore! È volontà di dominio, di possesso, ma mai amore. Nel libro vengono riportate alcune lettere scritte dalle madri di queste donne alle loro figlie. Scrive Giovanna Ferrari a sua figlia Giulia Galiotto (uccisa da suo marito): «Si può perdere una figlia, ma non così. Così si perdono anche i pilastri fondanti di tutta una vita. Perché la morte per femminicidio non cancella solo il sorriso e l’amore per la vita, ma nega il diritto stesso al sorriso e alla vita.» È un dolore a cui non si sopravvive, o meglio, si sopravvive perché i polmoni continuano a respirare, il cuore a battere, ma l’ultimo battito di vita vera è stato quello di un attimo prima di quella morte. Giuliana Reggio racconta che andò dai Carabinieri per denunciare l’ex fidanzato di sua figlia Jessica, ma i militari le dissero che così avrebbe rovinato quello che era solo un ragazzo: «E mia figlia, invece, cos’era?». Così Jessica fu uccisa a sedici anni con quarantadue coltellate dal suo ex, che oggi è libero, lavora ed ha una figlia. Paola Caio racconta invece che sua figlia Monica è stata uccisa dal compagno che non accettava il suo successo professionale, la voleva sottomessa; Monica si sentiva in pericolo, aveva telefonato alle forze dell’ordine: «La centralinista ha detto: quando sente la chiave nella toppa ci chiami. Monica ha protestato: ma il tempo che voi arrivate questo ha già fatto tutto, mi ha già bella ammazzata.»
Chi resta sopravvive con un grande e atroce interrogativo privo di risposta: cosa avrebbe potuto fare perché le cose andassero diversamente? Domenico, padre di Adele (nomi di fantasia) afferma: «Alle donne dico: non denunciate. La denuncia è pericolosa, incattivisce l’uomo. Se dovessi dare un consiglio, sarebbe questo: prendete i bambini e fate perdere le vostre tracce. Mia figlia voleva farlo, io l’ho dissuasa perché avevo fiducia nella giustizia. Le ho detto che sarebbe passata dalla parte del toro, diventando colpevole dell’abbandono del tetto coniugale con sottrazione di minori e possibile arresto. Ho sbagliato, non me lo perdono.»
E poi ci sono le figlie e i figli, “orfani speciali” nella definizione della professoressa Anna Costanza Baldry, che di aiuti e risarcimenti dallo Stato non ne vedono. Dice Giacomo: «Gli anni passeranno ma non riusciranno a dividermi dalla mia storia: è una cicatrice costantemente sanguinante, sulla quale viene buttato sale per non farla chiudere. Noi figli di madri uccise non abbiamo un problema psichico che passa con una terapia, ma un dolore con il quale dobbiamo imparare a convivere.» Ci sono anche le figlie uccise dai padri per punire le madri, alla faccia di tutta la propaganda dei padri separati. E poi ci sono le donne scomparse, quelle che nessuno conta, di cui non si interessano neanche quei trenta secondi di telegiornale, quelle la cui sparizione viene denunciata dai loro assassini.
La pubblicazione del libro di Stefania Prandi è stata preceduta da una mostra fotografica che, con lo stesso titolo, “The consequences”, è stata esposta a Bologna lo scorso anno (https://www.stefaniaprandi.it/index/G0000ZQsxBtYVhJM). Scatti che ritraggono persone, oggetti, ricordi, istanti, vuoti, rimpianti. Elena seduta accanto ad una sedia vuota, perché sua sorella non può più accompagnarla; i fiori che Letizia coltiva per portarli sulla tomba di sua figlia; il tatuaggio col nome di Giordana sul braccio di sua madre Vera. Istanti di ciò che resta e di ciò che è stato tolto. Istanti di vite cancellate dall’odio, dall’ignoranza e dalla presunzione, mai dall’amore.
Racconta ancora Giovanna Ferrari: «Io ero preoccupata per gli estranei: negli ultimi mesi Giulia parcheggiava in un garage sotterraneo, quando andava al lavoro, e io avevo paura che la sera, col buio, le potesse succedere qualcosa. Ero terrorizzata dall’uomo nero e non da quello in casa.» Ecco, forse la battaglia più difficile ma più necessaria combattuta da queste madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli è proprio quella di urlare – perché dire non basta più – che il posto più pericoloso per noi donne è quello che ci hanno sempre dipinto come più sicuro, che dobbiamo diffidare del nostro principe e non degli sconosciuti, e che dobbiamo credere in noi stesse e nella nostra forza per sopravvivere in un mondo che non sembra affatto interessato ad aiutarci a sopravvivere.
Link Esterno
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

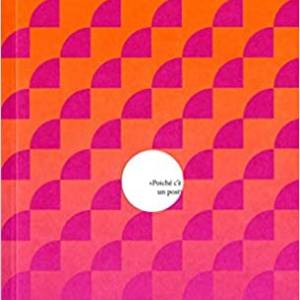



Lascia un Commento